
26 aprile 1976
Oggi sono andata alla casa dei frati. Sono scesa a piedi, da sola, dovevo portare il contratto. Credevo di trovare Filippo, come sempre, o Luca, invece alla porta mi ha aperto uno nuovo. Si chiama Sebastiano, è arrivato da Venezia due giorni fa, ha detto. Mi sono presentata, ma non so come mai non l’ho fatto subito, ci ho messo qualche secondo di troppo e lui se ne è accorto. Mi ha guardata piegando la testa di lato, una ruga profonda tra le sopracciglia, i suoi occhi avevano qualcosa di ipnotico, sono rimasta ferma sulla soglia, immobile, prima di decidermi a parlare. Sono sicura che lui se ne è accorto, è ovvio che se ne sia accorto.
“Mi chiamo Adele – ho detto – sono venuta a portare il contratto di affitto, credevo di trovare Filippo”.
Che frase ridicola.
“Filippo non c’è”, ha detto lui, e nel dirlo ha aperto del tutto la porta e mi ha fatto cenno di entrare.
Non ha spostato di un millimetro gli occhi dai miei. Ho tentennato come una stupida, come se quella casa non fosse casa mia, casa dei miei genitori, come se fosse stata la prima volta che ci mettevo piede, come se avessi avuto paura. Lui invece no, era tranquillo, ero io. Lo sentivo.
“Mi stavo facendo un caffè – ha detto lui – ne vuole? Ne vuoi?”.
Devo aver annuito solo con la testa, senza dire parola, come una ragazzina, lui mi guardava aspettando che allungassi la busta col contratto che tenevo in mano, la busta che ero venuta a portare e che tuttavia non gli davo, me la tenevo stretta addosso. Se gli avessi dato la busta non avrei più avuto un motivo valido per restare, forse per quello aspettavo, questo però l’ho pensato dopo. Lo sto pensando adesso che scrivo.
Lui deve averlo capito perché in un attimo ha ritirato la mano che prima sembrava aspettare. Si è voltato verso il fornello di quella cucina che per la prima volta mi è sembrata stretta, minuscola, lui invece lì dentro occupava tutto lo spazio.
“Zucchero ne vuoi?”
“Cosa?”
“Zucchero, o preferisci del miele?”
Parlava del caffè.
Non riuscivo a smettere di guardarlo mentre di spalle armeggiava con le tazzine e la moca, di guardargli quel collo tozzo su cui i capelli gli cadevano disordinati. Cosa c’era di bello in quel collo? Niente, Adele, non c’era niente, e allora perché non riuscivo né a sedermi, né a dare quella busta che tenevo ancora in mano, né a proferire parola?
“Zucchero, preferisco lo zucchero, grazie. Lei quando è arrivato? Da dove?”
Come mai non è arrivato prima, da qualsiasi posto sia? Questo non gliel’ho detto, è ovvio, questo me lo sono tenuta per me, ma sono sicura che lui ha capito che lo stavo pensando, l’ha capito anche se ho detto solo Da dove e quando, eppure volevo dire come mai adesso, per quale ragione sei dovuto arrivare, non potevi invece restare dov’eri, lontano da qui, da me e da questa casa, come mai oggi non sono andata con Anna Clara al fiume, come mai sono venuta qui io, devo andarmene subito, devo andarmene prima che lui si volti e mi guardi di nuovo con quegli occhi trasparenti, no, forse sono grigi, devo andare. Sebastiano.
Invece lui si è girato, ha appoggiato sul tavolo due tazzine sbeccate, come mai non mi sono mai preoccupata di lasciare in casa ai frati delle tazzine migliori, non sbeccate, domani porto delle tazzine nuove. Ha versato il caffè e poi lo zucchero nella mia, senza chiedermelo ne ha messi due cucchiaini, o forse me l’ha chiesto e io non ho sentito, forse ha sempre saputo che metto due cucchiaini di zucchero nel caffè, non lo so, ma l’ha fatto e io mi sono sentita nuda, come se lui sapesse già tutto di me, anche della macchia che ho sotto il seno o della cicatrice sul ginocchio sinistro. So che lui lo sa, Cesare non lo so, forse non ci ha mai fatto caso.
“Ma qui adesso avete un cane?”, ho chiesto e lui ha scosso la testa di no, eppure io sentivo odore di cane, e allora ho capito che doveva essere lui.
Avevo sentito l’odore della sua pelle appena entrata, un odore complesso e riposante, come di cose vecchie. Era lui che sapeva di cane. E la sua voce era la stessa cosa. Cane, cane, cane.
“Quella vuole lasciarla a me?”, ha detto vedendo che continuavo a non appoggiare la busta, né mi sedevo, né davo segni di bere quel caffè zuccherato.
Allora devo aver annuito, sì, sì, ecco, e l’ho appoggiata sul tavolo tra le due tazzine, ho sfiorato la mia, credo di averla girata più volte come quando sono soprappensiero, Cesare dice sempre che sono una donna distratta, con la testa tra le nuvole, che non ha mai conosciuto una donna più distratta di me, deve averlo notato anche lui perché si è come schiarito la voce, forse aspettava che io gli dicessi qualcosa, per esempio il mio nome, Adele, no, il nome glielo avevo già detto all’inizio, invece ho smesso di girare la tazzina e ho iniziato a mescolare lo zucchero col cucchiaino anche se lo aveva già fatto lui, non ho mai desiderato che lo zucchero non si sciogliesse, ma oggi l’ho fatto, l’ho desiderato, zucchero non scioglierti, se bevevo quel caffè poi sarei dovuta andare via, avevo già appoggiato la busta, che altro restava da fare? Adele, sei una stupida, sei una donna ridicola, che pensieri vai a fare, chiedere allo zucchero di non sciogliersi, sei sposata, hai una figlia piccola, lui è un frate, non lo vedi? Al polso tiene anche un rosario.
“Sono una donna sposata”, ho detto.
Lui mi ha guardata perplesso e ha annuito, un piccolo cenno del mento a indicare la mia fede, devo essergli sembrata pazza, ma un frate sarà abituato alla gente strana, tutti che vanno a confessare i propri peccati, le proprie pene, o forse no, chi lo sa, non so nemmeno se i frati confessano, non me lo sono mai chiesta, voi confessate? Come mai a Filippo non l’ho mai chiesto in tanti mesi che è qui. Mi posso confessare qui, adesso?
“Mia figlia si chiama Anna Clara”, ho aggiunto.
Lui ha sorriso di un sorriso benevolo, si capiva che gli facevo pena, tenerezza, solo dopo, quando ha riso, non riesco proprio a ricordarmi per quale motivo lo abbia fatto e non so come sia possibile non ricordarlo visto che sono riuscita, io, a farlo ridere nonostante quella ruga tra le sopracciglia, beh, insomma, ho pensato che forse invece era per non farmi vedere i suoi denti, ha denti stortissimi, eppure gli stanno bene, è un mistero, non ho mai visto una bocca così mal combinata, è proprio tutta la mascella che andrebbe rifatta, è troppo sporgente, non è adatta al resto, eppure lo è, quando gli ho detto che Anna si chiamava anche Clara per via della chiesetta dabbasso al Torcello ha sorriso di nuovo e quegli occhi da trasparenti hanno cambiato colore, si sono sporcati di qualcosa che mi ha ricordato la mia collana di giada, appena una screziatura, la prossima volta che vengo la metto, anzi no, non la metto, non devo metterla assolutamente, certo è un peccato perché è una collana bellissima e anche Cesare dice che quando la metto i miei capelli hanno un riflesso ramato, ma lo dice solo quando ne ha voglia, certe domeniche.
Non so per quanto tempo ho pensato alla collana, ma per tutto quel tempo Sebastiano stava in piedi davanti ai fornelli, finché un raggio di sole alle sue spalle ha svoltato l’angolo della finestra disegnando una lama sul pavimento. Vai via Adele, scappa, cosa fai ancora qui.
Con troppa lentezza ho appoggiato la tazzina sul tavolo, lui l’ha presa e l’ha portata all’acquaio, ha preso il bicchiere che avevo usato, l’ha riempito e ha bevuto, per molto tempo nella stanza è rimasto il silenzio.
“Vado”, ho detto, e lui ha annuito.
Quando sono uscita da lì, da quella casa, dalla mia casa, dopo aver bevuto il caffè ormai freddo, senza più una scusa per rimanere, la busta sul tavolo, tutte le spiegazioni date, mi sono dovuta fermare all’altezza dell’olmo a prendere fiato, le ossa mi facevano male, ho appoggiato la mano sulla corteccia e ho sentito che la mia mano era umida.
2 maggio 1976
Sono arrivata e mi sono seduta all’ombra dell’olmo. Non riuscivo più a stare a casa, Anna Clara piangeva dalle quattro, lei si accorge anche nel sonno quando sono nervosa e piange, piange, piange. Non so come fare quando inizia e non smette, Cesare lo sa e l’ha presa, ha iniziato a cullarla, lui è così: accudente, paziente, doveva nascere madre, io non sono mai stata capace.
Me ne sono accorta subito, dal primissimo istante, appena ho sentito il suo pianto, appena me l’hanno messa in braccio e mi hanno detto ecco questa è Anna Clara, che bella bambina.
Subito ho provato una fitta di gelosia nelle ossa e quando si è attaccata ho sentito che mi stava succhiando via la giovinezza, la bellezza e ogni possibile felicità insieme a quel latte annacquato.
Non avevo mai avuto seno e ne avevo orrore, ero diventata volgare, dozzinale, come le altre. Adesso Anna Clara me lo avrebbe svuotato quel seno, mi avrebbe svuotata dopo avermi riempita e finalmente sarei potuta tornare quella di prima, quanto tempo ci vorrà?, sarei potuta tornare me, Adele.
Cesare mi ha fatto cenno col braccio libero, quello con cui non la teneva, era quel movimento che voleva dire di andare a prendere aria, di farmi un giro, il suo sguardo era fermo per contrapporsi alla mia agitazione, rassegnato, a volerlo guardare bene, ma io non volevo guardarlo, avrei voluto esserne capace, avrei voluto annuire che era passata, invece sono uscita dalla stanza, ho approfittato della sua indulgenza, e mentre lui camminava avanti e indietro per il corridoio mi sono infilata il cappotto sopra la camicia da notte, le scarpe, le prime che ho trovato, ma mentre uscivo mi sono fermata sulla soglia, la mano già alla maniglia, e sono tornata indietro, ho imboccato le scale che portano sopra e in camera sono andata alla toeletta, ho aperto la scatola e l’ho trovata, era come la ricordavo. L’ho messa in tasca, ho richiuso la scatola, la porta della camera e rifatto le scale di corsa. Cesare mi ha guardata appena, avrà pensato che avessi infilato un maglione o tentennato, cambiato idea e invece no, sono passata accanto a lui e Anna Clara che già aveva smesso di piangere e anziché fermarmi perché non piangeva più sono uscita, ho preso il vialetto di ghiaia e aperto il cancello.
L’ho richiuso dietro di me con troppa irruenza, ma già stavo meglio, già riuscivo a respirare, ho aspettato di essere lungo il fiume e allora ho infilato la mano nella tasca del cappotto e l’ho toccata, era lì. Mi sono detta che sarebbe stato meglio comunque aspettare, era più prudente, e così ho fatto. Ho camminato fino alla spiaggetta, qui mi sono tolta le scarpe, dovevo bagnarmi i piedi, è l’unica cosa. Appena li ho infilati in acqua sono stata meglio anche se ancora potevo sentire il pianto di Anna Clara e vedere la rassegnazione nello sguardo di Cesare. Allora ho tirato su un poco il cappotto, fino alle ginocchia, e ho camminato con l’acqua che mi arrivava ai polpacci e dopo molto camminare sia il pianto che lo sguardo erano del tutto spariti. Così mi sono fermata, ho frugato in tasca e ho preso la collana. Alla luce dell’alba la giada aveva delle venature di ruggine che non avevo mai visto. L’ho messa, sono uscita dall’acqua e ho sfregato i piedi nella sabbia, ne ho presa una manciata e me la sono passata sulle gambe per farle asciugare, ho riso perché avevo gambe bianchissime adesso e chissà se i capelli erano ramati, non avevo niente con cui specchiarmi, ero uscita così, senza borsetta, come una che esce un momento, solo che ho camminato prima fino al fiume e poi fino all’olmo. Qui ho aspettato, ma non avevo niente da aspettare, perché lui non poteva sapere che ero lì, per saperlo avrebbe dovuto sentirmi, ma io avevo fatto piano, nessun rumore, o vedermi, ma l’olmo era almeno a venti metri, anzi di più, cinquanta, credo, dalla casa. Dovevo decidere se fare qualcosa per farmi sentire o vedere e alla fine mi sono detta di no, di non fare niente né per farmi sentire né per farmi vedere. Basta un pensiero che vola nell’aria. Se non lo si acchiappa ci si sente ancora più soli. E così sono rimasta appoggiata all’olmo, la schiena contro la corteccia, aspettando immobile che lui capisse e arrivasse, chiedendomi come sarebbe stato rivedere quei suoi occhi grigi o trasparenti a seconda della luce e quella bocca di denti storti, sentire di nuovo quel suo odore di cane. Poi ho smesso di chiedermelo e anche di sperarlo per potermeli solo immaginare, quei suoi occhi e quella sua bocca di denti stortissimi. Chissà da dove gli arrivano, da quale madre o padre o antenato, e sono rimasta lì a figurarmelo alla finestra, appena sveglio, a pochi metri da me, e la mia schiena era ormai corteccia e la mia mano sgranava la collana una pietra alla volta, e a ogni grano di quel mio rosario mi dicevo vieni, no non venire, corri subito qui, no, correre non sarebbe da te, capita, no, non capitare, arriva facendo qualcosa che già dovevi.
Ma se fosse arrivato cosa mai avrei potuto dirgli, che stavo solo riposando, prendendo fiato, che ero stanca e così ho camminato prima fino al fiume e poi dentro l’acqua e poi fino a lui? No, c’era da sperare che non lo facesse, che non arrivasse, perché non c’era nessuna scusa plausibile, nessun pretesto valido, lo sapevo bene, e tuttavia continuavo a restare, ad aspettare di sentirlo arrivare, di sentire quel suo odore di cane. Mi sforzai di riprodurlo nella mia mente, ma non riuscivo, e allora infilai una mano nella terra, scavai con le unghie e le annusai, ma la terra non aveva il suo odore. Adele, come sei sciocca.
Mi voltai e percorsi con lo sguardo il profilo della casa dei frati: una cascina senza poesia costruita solo per stare in piedi, prima non me ne ero mai accorta. Sollevai una mano e mi accarezzai il collo, chissà se dalla finestra lui mi poteva vedere, il solo pensiero mi faceva sorridere. All’ombra dell’olmo era violenta e dolcissima la malinconia del suo non arrivare. Intanto il pianto di Clara era sparito del tutto, lontanissimo ormai, restava un suono verde, di clorofilla, e io ero di nuovo Adele.
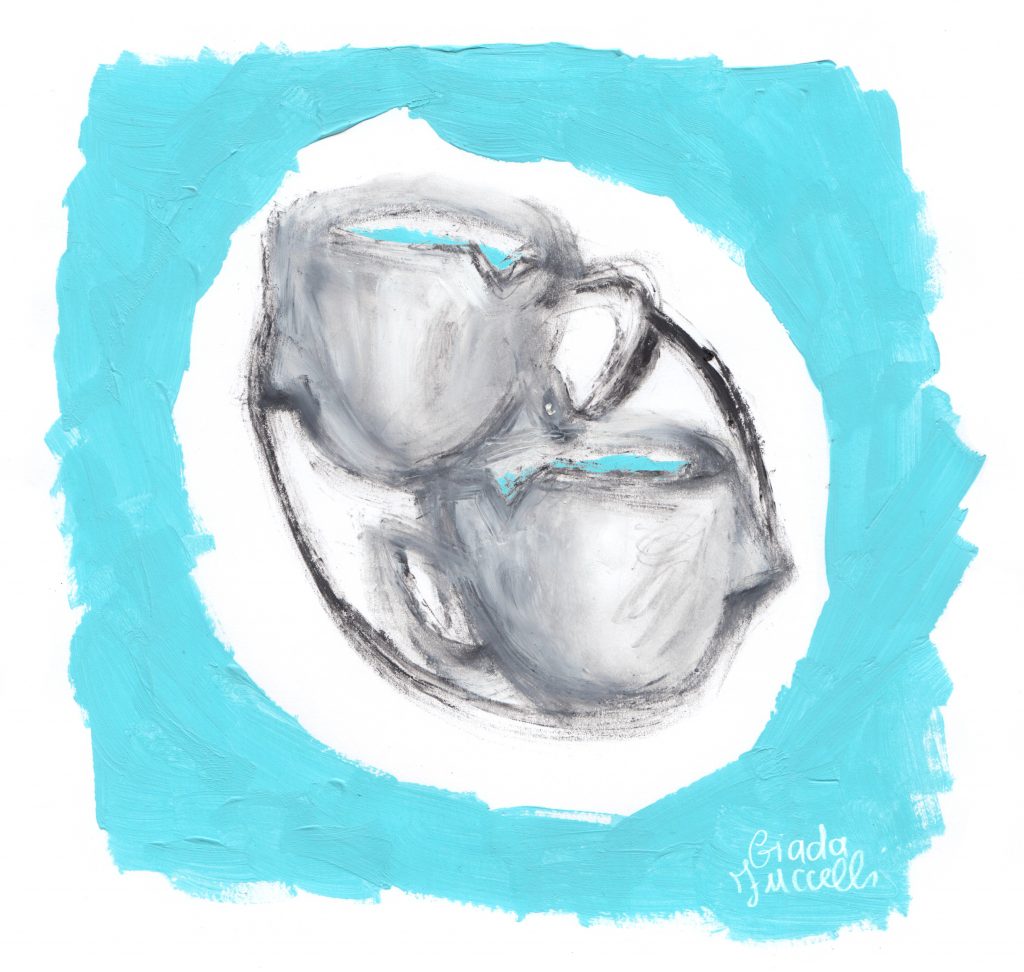
6 giugno 1976
La prima volta è stata alla spiaggia del Po.
“Ti rivedrò?”, gli avevo chiesto.
Albeggiava, i suoi occhi parevano muschio e palude. Potevo andare da lui quando volevo, aveva detto. Io volevo la sera stessa, e il giorno dopo, e sempre. Sebastiano aveva sorriso, tranquillo.
“E tuo marito?”
Aveva allungato una mano e mi aveva messo una ciocca di capelli dietro l’orecchio, io avevo scostato la testa con un movimento brusco.
“Cesare non sospetta”, avevo risposto.
Lui aveva annuito come quando intendeva no e invece diceva sì o viceversa, lo odiavo quando faceva così. Sembrava sapesse quello che mi passava per la testa e che lo sapesse prima di me. Nessuno mai aveva avuto su di me quel potere.
“Ne sei sicura?”, aveva ripreso.
Intanto aveva frugato nella tasca dei pantaloni, pantaloni di fustagno sdruciti, e ne aveva cavato fuori del tabacco che aveva preso a lavorare per raccoglierne tra l’indice e il pollice. Finì di riempire la cartina, le diede forma con due giri secchi e la leccò per la lunghezza a sigillarla, veloce.
Io non volevo che fumasse quando era con me, l’odore mi si attaccava ai capelli e Cesare non fumava. Lui intuì quel mio pensiero e si alzò, accese solo quando fu in riva al fiume, a vedermelo così in piedi, di spalle, alto, i capelli disordinati e l’alba che ridava i colori alle cose, capii che quello era l’amore e che mai, in venticinque anni che ero in vita, lo avevo provato. E che niente c’era di calmo o pacifico o sensato o giusto nell’amore. Mi sentii sciocca per la faccenda del fumo e mi sollevai anch’io, stirai con la mano le pieghe della gonna e lo raggiunsi alla riva. Sebastiano inspirò una lunga boccata e restammo in silenzio, io appoggiai la testa alla sua spalla, lui con la mano libera mi carezzò i capelli. Attraverso il fumo la piana liquida che ci separava dall’altra sponda si colorò di azzurro. Cesare non sospetta, ripetei a mezza voce e lui annuì brevemente. Qualcosa che già non aveva a che fare con i nostri due corpi lo turbava. Avrei voluto avere anch’io quel suo potere di indovinarmi i pensieri, ma sentivo che i suoi erano pensieri troppo lontani dai miei, che già lì, sulla riva, l’acqua che ci sfiorava i piedi, lui pensava pensieri che non erano i miei, né quelli di Cesare, pensieri che forse avevano a che fare col suo essere frate e con Dio o con quella ruga profonda che gli segnava la fronte a soli trentadue anni, ma non mi importava perché la sua mano grande, da soldato, non smetteva di carezzarmi i capelli e questo era tutto ciò che contava. Non c’era nient’altro.
12 giugno 1976
“Adele – mi ha detto – devi farmi un favore”.
“Quale favore, certo, dimmi.”
Sebastiano non ha risposto, ha solo stretto un po’ gli occhi ed è rimasto in silenzio. Faceva sempre così: teneva le persone sospese con quei suoi silenzi che sembravano la fine di una conversazione appena avviata. Seguiva anche lui con lo sguardo i movimenti di Anna Clara, seduta sul gradino dell’uscio, poggiata al muro giallo pastello. Le avevo messo il vestitino azzurro coi fiori, in mano stringeva un dente di leone. Le feci un cenno con la mano, frullandola in aria, lei allora soffiò e rise. Sebastiano rise anche lui, tutti i suoi denti storti in vista, gli capitava solo quando non faceva in tempo a tenersi, altrimenti il suo ridere era una smorfia che gli crepava con due rughe la barba non fatta.
“Quale favore, Sebastiano?”
Lui strinse gli occhi per la fatica di guardare controluce o per formulare quello che aveva in mente con le parole secondo lui giuste, ancora non aveva capito che non mi importavano le parole, mi importava di lui. Qualunque fosse il favore di cui aveva bisogno lo avrei fatto, che importava trovare il modo di chiederlo? Ma lui era fatto così e dal protrarsi del silenzio capii.
Il favore doveva essere grande e quindi molto lungo il silenzio. Allora mi alzai e raggiunsi Anna Clara, strappai un dente di leone anch’io e lo soffiammo insieme, guardando Sebastiano che questa volta sorrise solo con gli occhi. Era lì che doveva decidersi, forse con Luca e Filippo volevano chiedermi di ridurre l’affitto, lo avrei fatto comunque, già ci avevo pensato. Non mi andava più di fargli pagare per dormire nella mia casa, non a lui, almeno, mi sembrava che ci fosse qualcosa di innaturale in questo, qualcosa che stonava con i sentimenti che provavo per lui. Dovevo solo trovare il modo per convincere i miei genitori, una donazione forse, un’opera buona per una comunità religiosa, qualcosa del genere, un modo lo avrei trovato. Anna Clara mi salì in grembo e mi fece vedere un legnetto che aveva trovato, io le bacia la testa, sapeva di mandorla. Adesso che amavo lui riuscivo ad amare anche lei, era una cosa che avevo capito, quella, insieme a un’altra che mi vergognavo a pensare eppure pensavo lo stesso: quando eravamo noi tre così, al Torcello o alla casa, un po’ mi illudevo che fosse sua, non di Cesare.
Chissà come sarebbe stato, fosse stato vero. Forse era quella la felicità di cui parlava la gente. O forse la felicità vera era questa e la gente non l’aveva provata mai. Anna Clara gettò via il legnetto, non le interessava più e Sebastiano si mise a fare una delle sue sigarette. L’aria era pesante, carica d’acqua, eppure in cielo c’era un azzurro stampato senza sbavature. Un vento leggero muoveva le fronde dell’olmo. Stava per mettersi a piovere, questo era certo. Sebastiano portò la sigaretta alla bocca, ma subito la nascose nel palmo rinunciando a tirare. Mi alzai, dissi ad Anna Clara di raccogliere un dente di leone da portare al papà, che saremmo andate a casa tra poco, e tornai da lui. Mi ci fermai in piedi davanti.
“Ci sono dei documenti, Adele – disse spegnendo la cicca – dei documenti della fabbrica che devo vedere. Li ha tuo marito”.
Tutto quel tempo per una frase così.
Testo Stefania Maruelli
Illustrazione Giada Fuccelli