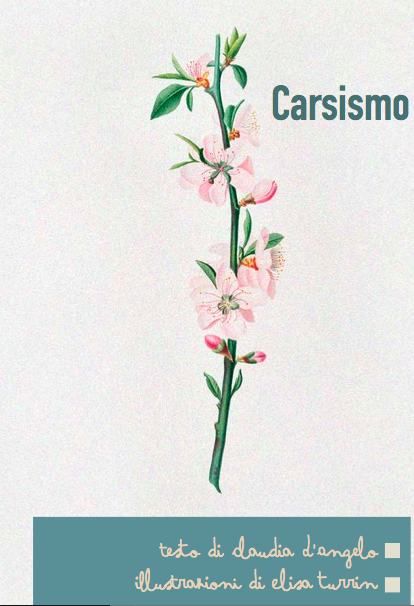
Mia mamma voleva a tutti i costi costruire lì. Lo aveva fatto zia Maria perché non farlo pure noi? Dopotutto, una volta costruito e una volta occupato, chi poteva buttarla giù? Si chiamava diritto alla casa. Si difendeva sempre così, anche con me: “Si chiama Diritto alla Casa, Coccinella, significa che tutti hanno il diritto a un posto dove dormire”, lo diceva a bassa voce, convinta che quello fosse il tono delle favole, ma era quello dei segreti. Mia mamma aveva l’abitudine di giustificarsi con me ogni qualvolta faceva qualcosa che veniva considerato illecito: e i pesticidi e il motore truccato e il cane dei vicini trovato avvelenato.
“Che disgraziata! – diceva mia nonna – Tu ce l’hai già una casa!”
Un’enorme crepa correva lungo il soffitto del corridoio, ironica ci indicava la strada dalla camera da letto alla porta d’ingresso. La nonna la percorreva in modo inverso, e non ci metteva niente a chiudersi dentro la stanza con la tv accesa finché non sentiva i passetti veloci di mia madre allontanarsi del tutto; usciva cauta, mi guardava vergognosa in viso per la sua arrendevolezza e si avviava sottovoce in cucina: disgraziata, disgraziata.
La nonna aveva paura che mia madre volesse demolire la casa, che avesse fatto un patto con zia Maria per venderle il terreno e costruire altrove, sulle terre coltivate. Sapevo tutto questo perché aveva l’abitudine di pensare ad alta voce, bisbigliava ogni giorno le sue discussioni immaginarie con mia madre, prevedeva le sue risposte, e se mia madre era più forte ricominciava daccapo con un’altra strategia, per poi tentare di metterla in atto quando la incontrava. Ma mamma era evasiva e refrattaria alla discussione, riusciva a cavarsela in qualche modo. Accadeva così: mia nonna tagliava due fette di formaggio, gliele metteva sul bordo del secondo piatto piano, sotto a quello fondo. Mamma dava dei morsetti mentre beveva il brodo e mia nonna intanto diceva: “Se vuoi possiamo mettere a posto la casa, puoi prendere i soldi che ho in conto e fai una bella ristrutturazione. Che ne dici?”
Mia mamma rispondeva: sì sì.
Allora mia nonna accarezzava il cappotto grigio di mamma sulle spalle prima che uscisse, le levava i pelucchi e diceva: “Maria ha fatto proprio un cattivo investimento con quel terreno, adesso sta con l’acqua alla gola. Mi prometti che non le darai nulla, quando… quando è il momento?”
Mia mamma rispondeva: sì sì.
Un giorno mia nonna aspettò che mamma si svegliasse e che scendesse in cucina per non servirle il caffè che non aveva preparato e dirle invece: “Rosaria, dimmi immediatamente che hai intenzione di fare con questa casa. La vuoi affittare?”
“Ma no, mamma – rispondeva – che vai a pensare, chi se la prende questa casa!”
“Allora la vuoi demolire!”
“Dio santo, e quante tragedie che fai!”
“Se distruggi la casa, Rosaria, e io sono ancora viva, ti taglio la testa con lo stesso coltello che uso per le galline.”
Mamma, ricordo, mi guardò per un momento, sembrava volesse capire da me se la nonna faceva sul serio. Smisi di sbucciare i piselli: il melodramma che aveva provato per settimane stava avendo inizio.
“Senti, Vincenza – superato il breve attimo di confusione, mamma si strofinò il viso con le mani che poi aprì sul tavolo – Io questa casa la butto giù perché se ne cade a pezzi da sé. Se non la butto giù io basta una scossa…”
“Tu non capisci! Sei nelle mani di Maria e non lo capisci!”, la sua collanina d’oro sgusciò fuori dalla maglia, e l’occhio azzurro indagatore del suo ciondolo scrutò me e mia madre per tutto il tempo della disputa.
Ci fu un’interminabile catena di accuse e difese, e alla fine la nonna se ne uscì dicendo: “Quel terreno è malato”.
Neanche rispose, mia madre, da parte sua ci furono solo occhi al cielo e mani in fronte.
La nonna continuò: “È malato, non lo sai?”
“Non è malato, ci coltivi lì sopra.”
“È fertile, ma perché non si può costruire secondo te?”
“Perché è di interesse archeologico”
“Perché è malato.”
“Ma che significa?!”
Era pronta, se l’era preparata; una breve pausa e infine la sentenza: “è maledetto”.
Mia mamma disse qualcosa tipo: Cristo e uscì.
Io ripresi a sbucciare i piselli, la nonna si unì a me; mi guardava tutto il tempo come se volesse mettermi in guardia da qualcosa: non disse niente; si accorse del ciondolo allo scoperto e lo nascose di nuovo tra i seni.
Circa sei mesi più tardi, dopo due attacchi di cuore, la nonna morì in un letto d’ospedale in mezzo a un mare di fiori: li avevo colti dal suo giardino per farla sentire a casa. Una volta, senza che la mamma sentisse, mi aveva raccomandato di tenere d’occhio sua figlia e aveva ripetuto: “quel terreno è maledetto”.
Casa nuova era impenetrabile: fuori avevamo piantato un giovane abete che copriva le finestre, intorno all’alto recinto siepi di rose di tutti i colori. Se qualcuno sbirciava non riusciva a vedere niente, se non forse la porta d’ingresso. Tra il garage e l’entrata c’era un’aiuola in muratura dove mi divertivo a fare i miei esperimenti floreali: la prima volta piantai dei tulipani, ma a febbraio del secondo anno ero indecisa e trascorsi il mese intero a studiare su internet i fiori e i loro significati.
“Il bucaneve è il primo fiore che spunta alla fine dell’inverno, per questo significa speranza. I fiori di pesco sono il simbolo dell’immortalità. E il papavero…”
“Tieni la malattia dei fiori”, diceva mia mamma.
Il fatto è che quel terreno era l’apoteosi della fertilità. Lei mi lasciava fare, ma qualche volta la vedevo di notte che gettava delle cose nel terreno. Di mattina lo ripulivo dalle cicche e non trovavo altro.
Anziché rose e fiori, però, all’interno della casa c’era un’insolita puzza di marcio.
Già a partire dai primi mesi avevo notato come un odore di andato a male in alcuni angoli della casa, odore che mia madre sicuramente avvertiva, e che subito si affrettava a coprire con diffusori elettrici alla lavanda. Alle mie insistenze sulle possibili cause, una volta mi rispose che si trattava sicuramente di un regalino che ci aveva lasciato la nonna.
“È arrabbiata.”
Motivazione che a me parve insolita detta da lei che mai aveva creduto a queste cose. Probabilmente aveva cominciato a crederci nel momento stesso in cui l’aveva detto, perché un giorno si diede la stessa risposta quando sparì la collanina d’oro: “Sarà ancora arrabbiata”.
E sbuffava, come se fosse plausibile.
Ma le cose continuavano a sparire, la puzza aumentava, addirittura dai soffitti cadeva acqua quando pioveva, e mentre la mia passione per i fiori si acuiva, l’entusiasmo di mia madre per la nuova casa calò del tutto e a tal punto che un giorno la sentii chiamare zia Maria al telefono.
“Voglio vendere la casa.”
Zia Maria aveva sicuramente riso, perché mamma poi aveva aggiunto: “No no, non sto scherzando, voglio venderla. Adesso la metto in vendita con tutto il terreno, me ne devo andare”.
Mamma era cambiata: era persino dimagrita. Si dava malata a lavoro e passava intere giornate a letto. Dapprincipio mi sembrò una benedizione, guardavamo i film accartocciate sotto alle coperte, poi cominciai a capire che mia madre non era affatto felice di vedere i film con me, e che anzi non era felice per niente. Era sempre distratta, qualsiasi cosa le dicessi veniva solo percepita per poi finire in qualche regione remota tra i suoi fittissimi capelli.
“Di quale gita parli?”
“Hai firmato l’autorizzazione ieri, mamma.”
“Ah, sì, è vero, scusami – si scusava sempre per le sue negligenze perché aveva tante cose da fare – ho tante cose da fare, tesoro”.
In effetti era vero, peccato non le facesse; ogni giorno era sempre più ossessionata e impaurita dalla presenza della nonna.
“Mi perseguita, Maria – continuò mia madre al telefono – mi perseguita. Ti ricordi la collanina? Quella che portava sempre? Sparita. E l’orologio, gli anelli… stamattina ho ritrovato la spazzola nel frigorifero”.
Zia Maria quella volta le consigliò di prendersi una vacanza, per staccare da tutto e da tutti – compresa me: prendersi cura di una figlia così piccola e lavorare, tutta sola, senza un aiuto, era difficile, doveva riposare un po’. Passai una settimana a casa di zia Maria, una casa insolitamente fresca, nessun odore di marcio e nessuna copertura alla lavanda. Ogni tanto entravo nel cortile di casa nostra per assicurarmi che i miei fiori stessero bene. Il giorno del ritorno di mia madre, nella mia bellissima aiuola in muratura, senza che io lo prevedessi né lo volessi, per volontà libera e indipendente, spuntò un papavero. Lo presi come un presagio.
Quando tornai a casa zia Maria mi caricò in auto in tutta fretta senza darmi spiegazioni. Non facemmo molta strada, la macchina serviva più da riparo dalla pioggia e dal tragitto fangoso. Arrivammo proprio dove era casa della nonna, adesso ripopolata dalla flora primigenia: graminacee verdi e gialle costellate da macchie rosse di papaveri. In mezzo c’era l’auto di mamma e, più avanti, mamma, completamente bagnata, con le infradito e i pantaloncini del mare.
Tra lo stridere dei tergicristalli consumati vidi le loro figure abbracciarsi: zia Maria riparava mamma dalla pioggia, mamma indicava il punto in cui si trovava la casa, come stupita di vederci l’assenza.
Mamma entrò in auto con gli occhi spalancati ma non sembrò neppure notarmi. Continuava a ripetere a zia Maria, rossa in volto: “Te l’ho detto che mi perseguita, mi ha portata lei qui”.
Al mio richiamo lei si voltò impaurita. Poi cominciò a piangere, allungò il braccio dietro di sé e mi accarezzò il viso. Chiesi: “Cos’è successo? Mamma stai bene?”
Ma niente riuscì a scalfirla, non parlò, le mie parole erano come colpi di piccone in una terra ostile: scavato il primo strato di terra incontravano una resistenza in un pezzo di metallo lasciato da qualcuno, o una consistenza sabbiosa antipatica, umidiccia, acqua addirittura che zampilla senza sosta e nessuna possibilità di fermarla.
Per sfuggire alla nonna andammo a vivere da zia Maria. Nonostante il cambiamento non rinunciai alle mie piante. Di nascosto da mia madre prendevo le chiavi di casa che zia Maria teneva in un cassetto del bagno e tornavo dai miei fiori: due volte alla settimana li pulivo dalle foglie morte, concimavo la terra con intrugli di caffè, bucce, a volte anche latte e resti di carne. Davo da mangiare alla terra che mi aveva portato via la casa. Inghiottiva tutto, vorace, e dalla lunghezza delle foglie, dalla lucentezza dei petali, sembrava reclamare sempre di più. Per un periodo una gatta sostò sotto all’aloe durante le giornate più calde: era incinta eppure non vidi mai i suoi cuccioli. In casa non entravo, avevo paura che la nonna si fosse incattivita ancora di più ora che l’avevamo lasciata sola, e che, non riconoscendomi più amore, si rivoltasse contro di me.
A tredici anni avevo più contatti col mondo vegetale che con mia madre. Da quello che cominciavo a capire, c’era qualcosa in lei di irragionevole: poco dopo il nostro trasferimento la nonna aveva cambiato anche i nomi alle cose.
“Rosaria – diceva zia Maria a mia madre – come si chiamano questi?” e le mostrava i piselli nello scolapasta.
“Lo so bene cosa sono! – urlava – Sono fagioli!”.
Poi un giorno, nel sistemare le mie magliette nel cassetto, scoprì la collanina della nonna.
Vidi la sua schiena irrigidirsi, le sue mani fermarsi, poi la sentii chiedermi: “L’avevi tu?”.
Presi coraggio e le confessai: “L’ho trovata l’altro giorno, nell’aiuola”.
“La tua aiuola?”
Scavando per piantare nuovi semi avevo visto l’oro scintillare nel terreno. Nel ciondolo a forma di triangolo l’occhio al suo interno mi scrutava privo di colore: l’azzurro della pupilla si era quasi del tutto perso.
Nel rivederlo mamma si ricordò di qualcosa. Quel qualcosa la turbò talmente che neppure si arrabbiò per la mia disobbedienza, prese le chiavi dal cassetto del bagno e si precipitò a casa. La seguii, aveva già cominciato a scavare nell’aiuola, devastando i miei gerani.
Tentai di fermarla, ma era una furia, le mani affondavano senza sosta nel terreno. Disseppellì l’orologio e qualche anello, ma li lasciò sopra al muretto.
Entrò in casa. quando la raggiunsi era in piedi nel salone, la mano sul tavolo, come per sostenersi, le chiavi strette nel pugno lungo il fianco: non emetteva rumore, non sentivo nemmeno il respiro, si stava trattenendo dal piangere. L’acqua che si era infiltrata aveva eroso le pareti e le colonne portanti in così poco tempo da dare al tutto un aspetto cavernoso, sottomarino. La muffa ricopriva a chiazze il soffitto, si era diffusa dagli angoli verso le restanti mura come una necrosi.
Era straordinaria la velocità del fenomeno. Il ramo dell’abete, spinto dal vento, batteva con insistenza alla finestra, e molto presto sarebbe entrato.
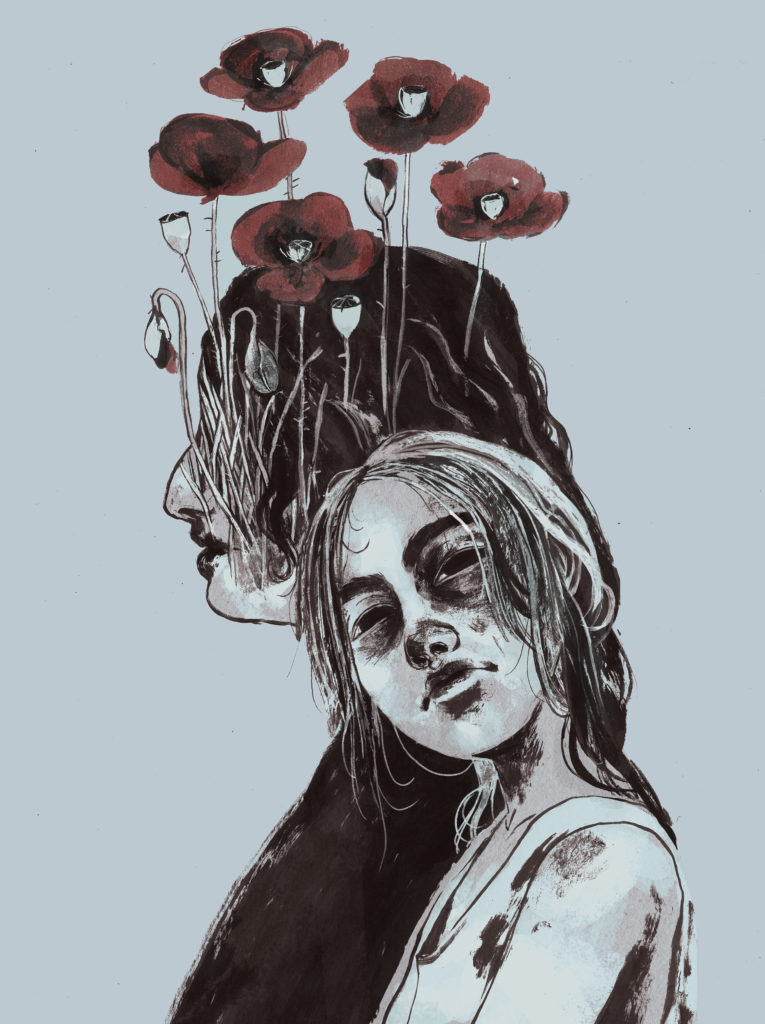
Quella casa non ci apparteneva più, se mai ci era appartenuta. In quel momento avevo la sensazione che sotto le fondamenta non ci fosse niente, che se le mani di mia madre avessero scavato un pochino più a fondo in quel terreno avrebbero trovato il vuoto, una via diretta e senza ostacoli per raggiungere il centro della terra.
Mia madre, in qualche modo, era diventata come quella casa: non aveva storia, non aveva legami o non li ricordava; era più che mai in balìa del tempo. Mi disse sottovoce una frase che non dimenticherò mai e poi mi ordinò di tornare da zia Maria. Non esitai, e i passi, dapprincipio nervosi, impacciati, diventarono fuga veloce da quella rivelazione: mi aveva detto, con dolore e spavento, che i fantasmi non esistono.
Mia madre tornò la sera tardi, rossa in viso e con l’aspetto offeso. Portava con sé una scatola che mise sul tavolo in cucina. Zia Maria le disse qualcosa, ma non la sentii, mamma rispose rovesciando il contenuto della scatola sul tavolo: tutti gli oggetti che aveva perduto.
Da allora smise di parlare della presenza della nonna e le cose si stabilizzarono. Mamma lasciò definitivamente il lavoro, ma anziché disperarsi, quel giorno portò a casa mezzo chilo di alici fresche che subito mise a friggere.
Se c’era pesce c’era festa e mia madre cantava mentre ripiegava i fogli di carta sulle alici appena uscite dalla padella, mentre le insaporiva col sale e se le portava alla bocca.
“Queste alici mi ricordano quando andavo al mare con Gianni, ti ricordi, Maria?”
“Gianni?”, ero incredula, mia madre parlava di qualcuno che apparteneva alla sua memoria.
“Tua mamma parla di quando aveva la tua età”, mi disse zia Maria.
“E scappavo di casa per andare al mare con Gianni.”
“Ti piaceva?” arrossii.
“Per non farsi vedere veniva col camioncino del padre, che faceva il pescivendolo – continuò mia madre – io dicevo alla nonna che andavo a vedere se c’erano le alici e invece mi prendevo un passaggio per andare al mare”.
“E la nonna non se ne accorgeva?”
“Certo che se ne accorgeva, dopo erano mazzate. Ma io poi le portavo veramente le alici!”
Rideva forte.
“Tesoro, mi passi il piatto per favore?”
Le allungai il piatto, lei prese tre alici con le mani e poi disse entusiasta: “Queste alici mi ricordano quando andavo al mare con Gianni!”.
Ridacchiai: “Sì, mamma, però non hai detto se ti piaceva”.
Ma mamma continuò a ridere e riprese: “Scappavo di casa per andare al mare con Gianni, veniva col camioncino del padre, che faceva il pescivendolo. Allora dicevo alla nonna che andavo a vedere se c’erano le alici e invece mi prendevo un passaggio per andare al mare”.
Rimanemmo tutte in silenzio, si sentiva solo lo sgranocchiare frenetico di Rosaria. Incrociai lo sguardo di zia Maria: mi fece il primo di una serie di sorrisi che poi avrei imparato a riconoscere. Presi il limone e lo spremetti sul pesce fritto; esitai, poi chiesi: “E la nonna non se ne accorgeva?”.
“Certo, erano mazzate! Ma io le portavo veramente le alici!”
Testo Claudia D’Angelo
Illustrazione Elisa Turrin