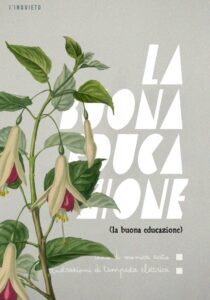
I professori, secondo gli alunni, si dividono in professori che scopano e professori che non scopano.
I professori che scopano, secondo gli alunni, hanno sempre l’estasi ricamata sulle guance, e i loro orgasmi si sciolgono in una pioggia di buoni voti, una grandine di regali scroscianti.
I professori che non scopano, invece, hanno la pelle grigia e le ragnatele attorno agli occhi: sono manovrati dagli organi genitali ormai incartapecoriti, molluschi freddi tra le gambe che non si piglia più nessuno, frutti di mare che non grondano più liquidi, umori, acqua.
I professori, secondo gli alunni, si dividono in professori che scopano e professori che non scopano.
Io sono una che scopa, ma loro non lo sanno, perché mi comporto da professoressa che non scopa: urlo, vocalizzo, sbatto le mani sulla cattedra e metto due sul registro come se la mia vita sessuale fosse quella di una vedova che passa la vita a cucirsi il lenzuolo funebre e l’imene.
Sbatto le mani sulla cattedra e mi piace farlo soprattutto quando indosso gli anelli di oro finto, così i miei alunni si spaventano a sentire quel rumore di nacchere rotte.
Urlo e mi si gonfia la vena in mezzo alla fronte, quella linea verdastra che a loro fa paura perché significa che prenderò una penna e scriverò una nota disciplinare, e loro correranno a casa e diranno che sì, hanno preso quella nota perché la professoressa Macrì è esaurita, è frigida e frustrata perché non vede un uomo manco col binocolo e quindi si sfoga sugli alunni.
A casa diranno che quel voto non conta, perché tanto glielo ha messo la Macrì, che non se la vuole chiavare nessuno, manco un cane spelacchiato con la rogna, ed è normale che la professoressa Macrì metta quei voti, perché la professoressa Macrì ce l’ha scritto in faccia che non scopa e quindi in qualche modo la professoressa Macrì s’adda sfugà.
Ma loro non lo sanno che invece io sono una che scopa.
Mai con uno fisso, è vero, perché attualmente sto andando a letto con il mio ex storico, che adesso non mi vede più come quella che gli preparava le lenticchie in umido e gli imboccava i farmaci col cucchiaio, ma soltanto come il rassicurante contenitore del suo sperma infrasettimanale.
Poi sto andando anche con un mio collega di sostegno più giovane di me, ma solo quando lui ha tempo; l’ho conosciuto durante le ore di compresenza.
Lui mi guarda mentre spiego e mi fa distrarre, ma io devo spiegare le poesie, devo parlare della cavalla storna di Pascoli e del chiù chiù dell’assiuolo e della nebbia agli irti colli e della siepe che all’ultimo orizzonte il guardo esclude, le uniche presenti su questo libraccio che si ferma ai limoni di Montale, ma gli unici limoni che mi interessano sono quelli tra me e un maschio, non questa roba che ripeto a pappagallo con gli occhi fissi sulla polvere del termosifone.
Al tizio di sostegno piaccio perché lui è un ragazzino di ventitré anni e io invece ne ho già trentanove, gli piaccio perché ho i peli scuri e neri, anche quelli in mezzo alle cosce, e non me li voglio togliere da là sotto perché mi fa impressione vedermi con quella cosa ianca comme ‘na palomma, come quella delle criature di dieci anni che non hanno assaggiato nemmeno l’ostia.
Questo ragazzino di sostegno ogni tanto sale a casa mia: è salito già cinque volte in realtà, ma non riusciamo a fare niente.
Per provare a farmelo entrare, mi devo sventrare e aprire tutta come un’ostrica, mi devo contorcere e fare mosse strane nella penombra, ma manco ci riusciamo: alla fine lui mi chiede scusa e io devo stare pure a consolarlo come una mamma mancata, devo ripetere sempre le stesse frasi bugiarde e da commediante e alla fine mi viene solo da rimettere. Rimaniamo là, per due ore, mentre lui dice scusa, scusa, non è mai successo poi si mette a giocare con l’Apple Watch e infine se ne va, come se nulla fosse successo.
In realtà me la faccio anche con un tizio del mio paese natale, che è il nipote di un politico locale, delle parti di Caserta: lui ogni tanto viene apposta da me a Milano e facciamo il giro degli alberghi, perché mi metto troppo scuorno di farlo dormire nel mio monolocale.
Il mio monolocale ha il letto matrimoniale attaccato ai fornelli e la mattina, quando mi sveglio, odoro tutta di minestrone; mi asciugo i capelli sul letto mentre con una mano giro la cucchiarella nella pentola, e le mie lenzuola sono sempre umide e hanno l’aroma del sedano e della cipolla ramata. Tra l’altro, il mio monolocale sta anche in una zona inguaiatissima di Milano, quando mi faccio la doccia sento sempre le volanti della polizia, perché il cesso affaccia sulla strada.
I miei alunni pensano che io non scopi mai, forse hanno anche ragione, perché sì, scopo, ma non con frequenza, dipende da come si mette la luna e da come si mette Venere nella terza casa del mio segno zodiacale, dipende da quando mi contattano i miei spasimanti, perché fanno tutto loro.
Io sono Toro ascendente Toro e i Toro sono pigri, sono segni di terra e nascono come prede, vogliono che facciano tutto gli altri: io non propongo mai niente, all’inizio fingo anche di non volerci andare ma alla fine ci vado sempre.
Ultimamente però l’ho incontrato uno che mi piace, a un corso di yoga che seguo quando il monolocale mi sta stretto e sono stanca di correggere i temi nella stessa stanza dove faccio colazione, pranzo, cena, dove mi asciugo i capelli e russo durante la notte. Vado a questo corso di yoga giusto per provare a me stessa di non essere murata viva, di non essere una che sta pagando il suo loculo a mille euro al mese spese incluse, perché il padrone di casa mi dice sempre che quest’anno i consumi sono una mazzata e non mi può chiedere di meno.
Questo tizio che mi piace si chiama Marco ed è di Conegliano Veneto, vicino Treviso, e fa il carabiniere a Milano.
L’altra sera siamo andati a mangiare thailandese e poi siamo andati a casa sua, perché ho detto che da me stavano facendo i lavori. Ci siamo messi sul letto, ci siamo baciati e io mi aspettavo qualcos’altro: invece lui mi ha detto “no, va là, io ti voglio solo guardare, fatti guardare, toccati”.
Lui si è steso sul materasso, tutto nudo, col mento prominente e il gomito puntato sul cuscino di seta, e si è messo a guardarmi mentre mi masturbavo. Io mi ravanavo dentro, mi aprivo con l’indice e il pollice, e lui mi guardava per quello che ero, un grande animale meridionale in cattività, una pantera inguaiata e maculata che si muoveva sul letto e faceva cigolare le molle, ma le molle cigolavano perché io stavo facendo tutto da sola mentre lui mi guardava.
Quando ho finito mi sono avvicinata a Marco e lui mi ha detto “No, basta così, domani ho la pattuglia all’alba”. Mi ha fatto ciao con la manina e poi si è messo una vestaglia, e io sono scesa nelle interiora della metropolitana.
Sono tornata nel mio monolocale e mi sono fatta una tisana al finocchio: ero la professoressa Macrì, la professoressa Macrì dannatamente sola che si masturba di fronte a un carabiniere veneto che manco la tocca, la professoressa Macrì con i vestiti che sanno di cavolo verza, minestrone bollito del Nord Italia, puzze che non sono nemmeno le mie, perché le mie puzze sono decise e prorompenti, mentre le puzze di questa città sono diafane, vellutate e lisce come teste di criaturi.
Anche il sudore degli uomini qui è diverso, è più dolciastro, se il sudore di questi uomini fosse un colore sarebbe il giallo paglierino, mentre io sono abituata al nero di seppia.
Mi viene il vuommeco a pensare di dovermi prendere cura e carico degli uomini, degli uomini e anche dei miei alunni.
Soprattutto dei miei alunni, dei miei sfaccimma di alunni, che mi fanno buttare il sangue ogni volta.

Finalmente stasera ho un appuntamento con il mio ex che è salito da Aversa, ce ne andiamo in un albergo, ovviamente pago io, perché il capocantiere dove lavora non lo paga mai. Lui ogni tanto va in cantiere e il fine settimana invece inforna le pizze in un chiosco vicino alle giostre di Aversa: per salire da me a Milano si svena.
Mentre sono col mio ex, capisco che lui è di buonumore e ci stendiamo subito sul letto.
Mentre lui è dentro di me, sento un dolore lancinante proprio tra le cosce, dove dovrei invece sentire delizia e sdilinquimento, dove lui mi ha sempre fatta godere, dove io ho sempre voluto sentirlo: non sono bagnata, non si può fare niente, qua dentro ci tengo la segatura.
“Prof, oggi è un po’ cattivella?”, il mio ex prova a penetrarmi, ma io non sono bagnata, sono fradicia soltanto del suono di questa frase.
“Prof, oggi è un po’ nervosetta?”, e mentre sono a letto col mio ex ricordo il ghigno di Martina C., che dice così tutte le volte che minaccio di scrivere una nota, ogni volta che sbatto le mani sulla cattedra mi apostrofa così, e tutta la classe ride appresso a lei.
Più mi accaloro, più provo a farmi valere, più lei mi guarda con occhi adulti e mi fa sentire un lombrico davanti a minorenni che sembrano conoscere la vita più di me. Alla fine la nota la scrivo sempre, e oltre a essere cattivella e nervosetta, per loro sono pure una che non scopa.
Ora però sto scopando, o almeno ci sto provando, il mio ex ci sta provando, ma io penso soltanto agli alunni che mi chiamano cattivella e nervosetta e che mi dicono che io non scopo, ma io in realtà sto scopando, vorrei tanto che mi vedessero così come sono, nuda con i capelli sciarmati, il trucco sbavato, il rimmel colato sulle guance come lacrime nere di terra, le cosce aperte che però sono aperte invano, perché non ci entra niente, non ci entra il mio ex, non ci entra il piacere, ci entra solo il dispiacere per loro che dicono che non scopo, che sono nervosetta, cattivella, e che sono così soltanto perché non scopo.
Piangerei tutto il pianto della terra, ma non mi viene più manco da piangere, e tutto il mio intuosseco se ne va in pancia, e lo stomaco mi rimane teso come pelle di tamburo, se ci batto un colpo sento duro.
Il giorno dopo torno in classe e l’alunna nuova, Larisa, è molto attenta mentre sto spiegando Dante: sto spiegando il canto del folle volo di Ulisse, il ventiseiesimo dell’Inferno, quello che dice che non siamo stati creati per vivere come bruti ma per seguire virtute e canoscenza.
Snocciolo, spiego, ripeto, regalo ai miei alunni perle a cui non credo e che ho letto prima di entrare in classe, perché io non la conosco poi così bene la Divina Commedia: dico loro di non vivere come bruti, ma di seguire sempre la ragione, la virtù e la conoscenza, appunto.
Mi seguono soltanto in tre: Samuele, il ragazzino che sta al primo banco e che mi fa sempre domande, ma io lo arronzo perché c’è casino in classe e le sue domande mi fanno perdere il flusso di spiegazione che con fatica riesco a creare; il ragazzino nuovo arrivato da poco, perché se non capisce la lezione, poi arriva la madre a protestare a scuola con altre mamme e insieme iniziano a incatenarsi ai pali della luce, a chiamare i giornali, a fare gli scioperi della fame e, inspiegabilmente, oggi mi segue pure Larisa, l’alunna nuova.
A un certo punto però Larisa decide che non mi vuole seguire più: “L’argomento è bello ma lei non lo sa spiegare”, dice sottovoce a Martina C., che sta con gli occhi sul cellulare, ma io fingo di non vederla.
Il professore di sostegno mi dice, mimando il labiale: “Continua! Non ti fermare, continua a spiegare!”.
Io continuo a spiegare e parlo di come la nostra vita debba essere votata al conseguimento della virtù, al raggiungimento di un bene superiore: mentre lo dico c’è Marco Q. che fabbrica palline e proiettili e aereoplanini di carta, Leo H. che fa TikTok col cellulare e poi c’è Sannicandro, l’alunno col padre in carcere, che la preside ci ha espressamente vietato di sgridare perché sennò rovescia le sedie, i banchi e i docenti, quindi non bisogna mai rimproverarlo. Sannicandro sale in piedi sul davanzale e saluta i vecchietti e i muratori che passano sul corso e gli fa dei video da mettere su Instagram.
“Dovete seguire virtù e conoscenza”, continuo a ripetere, ma gli alunni più bravi mi rimproverano con lo sguardo, perché io in quel momento incarno per loro la massima autorità dopo di Dio e prima dei loro genitori e non sto facendo niente, uno sfaccimma di niente.
Mi sento bruciare di schifo e vergogna fin dentro il midollo e gli intestini, capisco che devo fare qualcosa, lo leggo nello sguardo degli alunni che mi seguono: allora mi alzo dalla cattedra e vado a sequestrare il cellulare a Leo H.
Leo H. però mi ride in faccia e serra il telefono nel pugno per non farselo sfilare:
“Perché non sequestra pure quello di Sannicandro? Perché lui non lo punite mai? Perché soltanto io? E che sono io, il figlio della gallina nera? Cos’è questa storia?”
Lo guardo, non posso manco dire niente, perché questo ragazzino puzzolente, acneico e segaiolo tiene ragione.
Noi docenti non possiamo dire niente a Sannicandro, ce lo ha detto la preside, ci ha detto che Sannicandro in classe può fare quello che vuole, anche pubblicare i nostri video su Instagram, smutandarci, lanciarci i cancellini dietro, organizzare rappresaglie a suon di gessetti colorati o intonare serenate zozze rivolte alle bidelle, ma lui è sempre giustificato perché ha il padre in carcere e già c’ha i problemi.
Leo H. mi guarda con le sopracciglia alzate, un puntino di bava gli trema sul labbro superiore, come una piccola perla sporca.
“Scusa allora”, dico a Leo H. e smetto di chiedergli il cellulare, come una criaturella scema a cui il papà fa notare i buchi nel suo ragionamento bambinesco.
Leo H. mi guarda con clemenza e poi riprende a tiktokeggiare più tronfio di prima, scambiandosi uno sguardo complice con la marmaglia dei compagni che dopo lo celebreranno come eroe, perché ha fatto il cappotto alla Macrì, la professoressa che non scopa, l’ha praticamente fatta capa ‘e cesso.
Mi sento qualcosa dentro, come una piovra viscida che sbatte ovunque i suoi tentacoli oleosi. Ritorno alla cattedra e riprendo a sproloquiare su Dante, virtù e conoscenza.
Ormai non so più cosa sia manco la dignità, quando ti metti a fare questo mestiere firmi col sangue una clausola in cui rinunci a ogni tipo di rivendicazione di fierezza, intelligenza o altro; non so più cosa sia nemmeno la vergogna, infatti riprendo a spiegare come se nulla fosse, tutto viene tamponato da una garza che è nascosta da qualche parte nel mio corpo, mi passo un fazzoletto gigante sulla bocca umida dello stomaco, tutta la rabbia rimbalza in qualche parte di me che non conosco e poi riemerge di notte, mi risale sulla bocca sotto forma di fiotto acido oppure mi risale dal pube mentre sto facendo sesso, ma mi risale sotto forma di secchezza, blocco e siccità.
Quando un docente riesce a gestire gli alunni, si dice che “sa tenere la classe”.
Io la classe non la so tenere, e quando io ed Emilia Pinto, la docente di inglese, ci diamo il cambio, gli alunni si mettono tutti sull’attenti, sembrano soldatini di piombo, fiammiferi spenti che si mettono in piedi e la ossequiano.
Con me, invece, fanno quello che vogliono, perché io non so tenere la classe, e loro se ne accorgono: agli alunni non puoi nascondere niente, ti entrano nel corridoio dei pensieri, edificano stanze nella tua mente e si ficcano nel letto pure mentre stai chiavando, ti fissano nella penombra mentre lo stai prendendo in bocca, sono degli spiritelli cattivi a cui non posso celare nemmeno i miei pensieri più segreti, hanno gli occhi appuntiti e lucenti come quelli dei roditori. Io non so più cosa fare con questi alunni, vedo le loro code che sgusciano ovunque, il sabato e la domenica non lavoro e rimango nel letto fino all’una, perché mi sento il canale di scolo dell’umanità, come se tutto il materiale di scarto del mondo si fosse calcificato sulla mia pelle e io fossi fatta di squame di nausea.
Certi giorni mi chinerei sul cesso e mi metterei a vomitare ogni lettera del mio nome e del mio cognome, mi metterei a vomitare i miei capelli, le mie ciglia, le pupille dei miei occhi liquefatti, tirerei lo sciacquone e andrei a inquinare qualche oceano con quello che rimane di me.
Io non ci voglio più entrare in classe, io non le voglio più sentire le mie colleghe che in sala docenti si organizzano per fare attività, lavori di gruppo, cooperative learning, flipped classroom, proiezioni di video, uscite didattiche, io non so insegnare, e sto facendo questo solo perché non so fare niente altro. Non ero brava a scuola, non eccellevo in niente, avevo tutti 6 e mezzo e mai 7 e 8, anche la triennale me la sono presa a spizzichi e mozzichi e un anno mi volevo pure fermare, non ero come quelle brave che erano brave proprio perché rielaboravano, creavano, inventavano.
Con i miei colleghi, non vado oltre il buongiorno: il professore di musica è un aspirante musicista, suonava il sassofono e voleva diventare la stella dei sassofonisti, il John Coltrane di qualche banda o filarmonica o alla Scala, e invece ogni mattina ha la faccia di uno che dalla scala ci è proprio ruzzolato e si ritrova a dover cantare la sigla di Mare fuori insieme a dei minorenni sudati. La professoressa di francese, invece, faceva la guida turistica ai crocieristi in pullman e se ne andava in Corsica, ma quello che guadagnava non le bastava nemmeno a comprarsi una paletta da alzare per farsi vedere dai turisti che si perdevano sotto la casa di Napoleone.
Quella di inglese, Emilia Pinto, è una signorotta dai capelli ricci ed elettrizzati, un donnone che marca il territorio: ogni volta che si piazza in classe, sembra che in quel preciso punto dell’aula spunti una sequoia; passa il tempo a proiettare video di “Magic English” e a mangiare salatini che sanno di fegato alla veneziana e poi si toglie le rimasuglie dai denti con le unghie arcuate come ramponi.

Oggi Martina C. ha esagerato.
Mentre spiegavo la latitudine e la longitudine nell’ora di geografia, per sbaglio ho confuso meridiani e paralleli perché l’ultima per me è particolare: all’ultima ora, io in realtà non ci penso a cosa sto spiegando, perché non vedo l’ora di correre in macchina e fiondarmi nel mio monolocale, per apparare una bella piadina farcita di speck in offerta, mozzarella cruda, rucola in busta e maionese mischiata con la salsa barbecue, pure quella in offerta.
“La Macrì non sa manco cosa sono i meridiani e i paralleli, forse le manca la prima media”, Martina C. bisbiglia a Larisa, l’alunna nuova, e quando Martina C. bisbiglia, sembra una piccola volpe. Larisa annuisce e Martina C. le dice, scandendo bene le parole: “Lo tiene scritto in faccia che nemmeno stanotte ha scopato”.
Larisa ridacchia e mette un astuccio davanti al musetto, e Martina C. scandisce di nuovo bene le parole: “Se scopava, vedi come se li ricordava bene i meridiani e i paralleli!”, e Martina C. e Larisa fanno dei cerchi con le dita e dentro ci infilano dei pennarelli, poi li tolgono e ce li infilano di nuovo, si mettono a stantuffare con le dita pensando che io non le veda.
Termino la lezione di geografia, dopo un quarto d’ora è tutto finito e posso spegnere le luci della classe. Spengo anche la lavagna elettronica luminosa, spengo il computer, ripongo il registro nel cassetto, controllo se ho dimenticato qualcosa sulla cattedra, ma sicuramente quello che non trovo sarà nel mio armadietto.
“In fila, ragazzi, in fila per due”, urlo con una voce scarica, e controllo se i ragazzi stanno in fila, ma Leo H. zompetta come un grosso grillo maleodorante e fa Tik Tok con canzoni di rapper napoletani che parlano di bitch e money, mentre invece Martina C. e Larisa continuano a ridacchiare tra loro a braccetto, strette l’una all’altra come bisce gemelle.
Finalmente il suono messianico della campanella pone fine alla giornata, lo squillo di trombe degli angeli: apro il recinto, libero le bestie ed è tutto un vociare, un diluvio di urla gutturali, di esalazioni da scimpanzé, vedo piedi che volano, mani che tastano il terreno, spacchi di culi che fuoriescono dai jeans per la freva e la frenesia della corsa oltre il cancello.
Anche io esco fuori e cerco la mia macchina, grata per la fine di un’altra giornata, eccitata perché non vedrò Leo H., Marco Q., Martina C. e Larisa fino al giorno dopo, assa’ fa’ ‘a Maronna.
Cammino verso l’auto e già sento sulla lingua il sapore di plastica e di stalla e di fieno dello speck in offerta, bello grufolante, voglio scrivere al mio ex che non mi risponde da ieri, nemmeno stamattina mi ha pensata, ma quando mi tasto la coscia non sento il duro del cellulare, che di solito è ben riposto nella tasca.
Inizio a toccarmi tutta, inizio a compulsare mentre mi sfrego e mi ispeziono dalla testa ai piedi, ma il cellulare non ci sta: prendo la borsa e la rovescio malamente sul sedile del passeggero, e dalla borsa escono solo le Philip Morris Blu, i pacchettini di cracker ridotti a truciolato, i biglietti della metropolitana, accendini colorati lucenti come caramelle.
“Prof, cerca il cellulare? Le è caduto mentre usciva, Marco Q. e Leo H. l’hanno spinta!”
Martina C. corre verso di me, trafelata e con le scocche rosse.
“Eccolo, l’ho raccolto, sennò glielo calpestavano e glielo rompevano”, e mi porge il telefono, come se mi mettesse un piccolo dono nelle mani.
Non avevo mai guardato bene Martina C.: vista da più vicino, pare ancora più piccola.
Ha gli occhi talmente azzurri da sembrare neri, un sigillo strano le risplende nelle pupille. Sembrano truccati di neretto e invece hanno già le ombre scure di una vecchina.
Ha qualcosa di puerile nel modo di posarmi il telefono in mano, una delicatezza goffa da scoiattolo preoccupato e ha l’alito affannato che sa di cioccolato al latte. Afferro il cellulare e me lo rimetto in tasca, velocemente.
Martina C. rimane in piedi a guardarmi, di fronte alla mia macchina, stringendosi nello zainetto.
“Vieni, ti do un passaggio, così mi sdebito e oggi non prendi il pullman”, e le faccio segno di salire.
Martina apre lo sportello, eccitata all’idea di salire in macchina con una professoressa, si sente speciale, si sente più grande, non riesce a nascondere i lampi di gioia guagliona che le si arrampicano sulle braccia, sul collo, come uno stuolo di formichelle.
Le chiedo dove abita, lei non s’arricorda, quella sta sempre distratta, ma ci pensa un po’ e poi dice il nome di un posto in periferia, dove non sono mai andata in macchina. Riprendo il telefono dalla tasca e accendo il navigatore.
Ci mettiamo più tempo del previsto, casa sua si trova assai lontano e sbaglio la strada otto volte.
Nel frattempo passa un’ora e io continuo a non raccapezzarmi: Martina C. mi chiede scusa mille volte, si sfrega le guance rosse e per due volte mi dice “No, prof, ormai è tardi, ora scendo dalla macchina e torno a casa a piedi”, e si agita per la vergogna, come un’alicetta che sguscia nella rete, ed è pronta a mettersi a sgambettare da sola tra palazzoni di cemento e strade anonime e blu polvere. Ma io non c’ho cuore di farla scendere, le dico che stiamo arrivando, che forse ho imboccato la strada giusta.
Martina C. ha fame e vuole mangiare, e in realtà pure io una cosarella me la mangerei, visto che ormai la piadina me la faccio stasera. Presa dalla smania della fame e dell’imbarazzo di trovarsi con me, Martina C. sembra bellina, ha cambiato faccia, non è più guappa come quando sta in classe, ma il viso si è sciolto e gocciola bontà di bambina, di colombina.
“Com’è questo bar? Lo conosci? Ora ci sediamo un attimo qua”, sorrido e fermo la macchina nei pressi della prima brutta caffetteria che mi si para di fronte. Anche Martina C. mi sorride.
Prendiamo due panini con insalata, pomodorini e cartonato freddo che deve essere cotoletta. Mangiamo con appetito, Martina C. si fa portare anche una bustina di maionese e prova a spremerla sulla cotoletta: la apre in modo sbagliato, non riesce a fare uscire la maionese e allora la aiuto io.
Mentre morde il panino mi dice Grazie con la bocca piena e gli occhietti liquidi che ridacchiano.
Mangiamo silenziosamente, si sente soltanto il rumore della deglutizione stopposa e l’impercettibile effervescenza dell’acqua frizzante nei bicchieri di plastica.
“Posso andare in bagno? Non la trattengo più” dice Martina C. mentre mangia l’ultimo pezzo di panino, con un po’ di scuorno.
“E mica siamo a scuola? Non devi chiedermelo”, le dico io pulendomi gli orli della bocca, pieni di salsa.
Tutte e due scoppiamo a ridere.
“Ma lo devo chiedere al barista, vero?”, mi incalza Martina C. mentre si succhia i polpastrelli lucenti d’olio.
“E certo, a chi lo vuoi chiedere?”, la rimprovero placidamente, e nel frattempo raccolgo anche la bottiglietta di plastica che lei ha menato per terra.
“Io mi vergogno a chiederlo al barista, chiediglielo tu – e Martina raccoglie l’ultimo pezzo di pomodoro verdastro che era sgusciato via dal panino, – glielo devi chiedere tu, io non voglio”.
Non perdo nemmeno più tempo a farle capire che mi deve dar del Lei, che sono sempre la sua professoressa, non la cugina carnale, ormai non ci perdo manco più il fiato.
Mi alzo e chiedo al proprietario del bar dove è il bagno.
Lui sta sciacquando le tazzine di caffè, sta scrostando gli aloni di rossetti antichi sulla porcellana scadente: mi guarda, si avvicina e riesco a vedere un porro che ha vicino all’orecchio.
“Ti devo dare la chiave, sta fuori”, dice con una voce femminile, una vociarella in falsetto.
Mi faccio dare le chiavi ed esco fuori insieme a Martina C., che si lamenta dicendo che se la sta facendo addosso e che non può più trattenere, che tra poco la fa in mezzo alla strada come i cani, tanto nessuno la vede.
Individuiamo il bagno, sta a duecento metri dal bar, nemmeno tanto lontano da dove ho parcheggiato la macchina.
Infilo la chiave nella toppa e Martina C. entra nel cesso come una piccola furia, dicendomi: “Faccio subito, mi servono i fazzoletti, me li puoi dare?”.
Prendo un pacco di Tempo dalla borsa e glielo allungo. Lei sbatte la porta.
Sento il filo di pipì che esce dalla vescica di Martina C., immagino la sua vagina piccola con i peluzzi che sono appena spuntati, la immagino pulirsi con i miei fazzoletti. Vado ad aspettare Martina vicino alla mia macchina.
Un piccione mi si avvicina e ho un moto di vuommeco a mille pesti, sbatto i piedi per terra per farlo andare via. Mi guardo intorno e mi appiccio una sigaretta nell’attesa.
Martina C. ha finito di fare pipì da un minuto. Poi da due minuti, che scivolano verso i tre.
Mentre salgo in macchina, con la sigaretta ancora accesa, la sento urlare da dentro il bagno. “Professoressa, mi puoi aprire? Mi apri? Non riesco a uscire!”
In macchina c’è puzza di tabacco e getto le chiavi del bagno sul sedile. Il telefono mi squilla: finalmente, dopo una settimana di sparizione, ricompare il mio ex.
Metto in moto la macchina e mi metto a cantare, canto sempre più forte e la voce non sembra nemmeno la mia. Continuo a cantare e urlo così tanto che non penso alla voce di Martina C. chiusa nel bagno, Martina C. che mena i pugni sulla porta, Martina C. che bussa e batte e graffia sulla porta, Martina C. che mi sta ancora chiamando.
Testo Monica Acito
Illustrazioni Tempesta Elettrica