
Da tre mesi sei in città; da una valle dove si sogna per sopravvivere, in attesa di scappare. Sei finita in un monolocale, trenta metri quadri in un condominio con vista su altri condomini. Palazzi che nascondono il sole dall’alba a prima del pomeriggio, persone che s’incontrano solo per coincidenza d’orari, si salutano in ascensore o mentre scremano bollette dalla pubblicità. Sei in città perché vuoi lavorare nell’editoria, anche se i pochi che conosci e che ci lavorano ti ricordano te stessa nella valle.
Il master inizia tra due settimane; nel frattempo, da industriosa laureata, riccioli neri e culo sodo, fai la cameriera, conti mance e scansi rattusi. E prima di attaccare a lavoro chiami mamma e papà, dici loro che va tutto bene, che te la cavi alla grande. A volte, quando riattacchi, piangi, e non sai perché.
Quella sera avverti una fitta di solitudine e incertezza. Il pensiero d’aver sbagliato ti raggiunge. La tua vita deve ancora cominciare, eppure è già pronta a sbandare al primo bivio. Ti domandi se altri, nel palazzo, condividano un’ansia simile, sempre in agguato. Pensi che, in fondo, non lo scoprirai mai, perché non conoscerai nessuno, potresti crepare e saresti licenziata prima del ritrovamento del corpo; ed ecco che l’ansia aumenta. Poi ti dici che col master le cose cambieranno, sarai con persone che hanno i tuoi interessi – chissà da dove scappano, i loro sogni, cosa inseguono – e allora l’ansia un poco ritrae gli artigli dal cervello, e il sonno è la carezza che meriti.
Ma quella sera scopri qualcosa di nuovo: l’uscio del monocale va chiuso a chiave, girando bene bene. Altrimenti basta spingere e la porta si apre, come nelle sit-com americane, dove uno irrompe e parte l’applauso, dice la battuta e scoppia la risata metallica. Lo scopri perché, mentre sei cullata dal sonno, qualcuno irrompe nell’appartamento. Nessuno ride o applaude, la tua mano si catapulta sull’interruttore della luce. D’istinto prendi il cellulare. Sono le cinque del mattino, lui è alto e dinoccolato; della tua età, di sicuro più forte. Chiude la porta, tre passi e si avventa sul letto. Pensi che se ti muovessi di scatto sarebbe peggio, allora resti immobile mentre si piazza sopra di te, in ginocchio, le mani sulla fibbia e poi sui bottoni dei jeans.
Dice: “Oh, scopiamo”.
Il puzzo di vodka distrae dal terrore, ti ascolti mentre immobile dici: “Perché?”
E lui: “Come perché?“
E tu: “Sicuro di volerlo?“
Lui molla la presa, sbraita: “Ma vaffanculo, m’hai fatto passare la voglia, stronza”.
Si butta sull’altra piazza, inizia a russare mentre fissi congelata il bianco del soffitto. Quatta come fossi tu l’intrusa, in punta di piedi scalzi fili in bagno e apri i rubinetti. Mica ricordi se va chiamato il 113, il 118 o il 119, allora digiti sul motore di ricerca “cosa fare in caso di tentato” e ti fermi, perché la mano trema troppo a scrivere strupro.
Quella parola non ti era mai venuta addosso; al massimo approcci insistenti e viscidi, o l’inquietudine nel camminare da sola, di notte, cambiando lato della strada a ogni uomo che ti incrocia.
Strozzi le lacrime, completi la frase; bestemmi sottovoce, perché i primi risultati vogliono spiegarti la differenza tra stupro, abuso e molestia, vogliono insegnare alla tua paura cos’è giusto e reale. Poi pensi che è stato solo panico; non c’era bisogno di cercare, era solo una finestra di tempo per far tornare il respiro normale.
Schiacci i tasti come per punirli, attendi in linea; alla fine una voce risponde. Sussurri il tuo indirizzo, spieghi che l’aggressore dorme nel letto, rispondi che no, è un perfetto estraneo. L’uomo al centralino ti chiede di alzare la voce, non capisce nulla, se non che sei signorina. Allora impari che è possibile gridare sottovoce, e quando riagganci – la pelle gonfia di stanchezza paura e pianto fili al piano di sotto in attesa della polizia.

Quando arrivano capisci che sta succedendo davvero. Prima no, era come quando ti svegli per scoprirti in un’altra regione dell’incubo.
Sono una donna e due uomini. Lei chiede sei hai freddo; dove si trova l’uomo, se hai chiuso la porta. Se hai con te la chiave. Rispondi meccanica mentre gli altri due salgono; lei sciorina frasi imparate in corsi di aggiornamento per gestire i traumi. Ti offre una sigaretta, ma rifiuti: non si può fumare nell’androne, e uscire all’alba in pigiama di pile, senza pantofole, non sembra una buona idea. Allora ti chiede perché sei in città, così spieghi che vuoi lavorare nell’editoria, e la donna sembra quasi rassicurata.
Dice: “Be’, sicuro questa è una storia da raccontare!”
Pensi: deve averli seguiti controvoglia, quei corsi.
Lei continua a parlare, tu annuisci assente, finché non riconosci le coppie di passi autorevoli, di scarpe basse e tonfi accennati.
I due poliziotti ricompaiono, il più basso dice: “Ora è a posto, è stato un malinteso”.
Ripeti la parola: malinteso?
L’altro, brizzolato e fuori forma, pulviscolo di forfora sulle spalline, alza gli occhi al soffitto, poi dice: “Era così ubriaco che ha sbagliato appartamento. Sta al primo piano, proprio sotto di lei, signorina. L’ha scambiata per la sua ragazza. Evidentemente non ha chiuso bene la porta, altrimenti non sarebbe riuscito a entrare”.
Interviene la collega: “Oh, meno male, se era davvero uno stupratore poteva riprovarci, visto che sa dove abita”.
Quello basso nota il tuo sguardo attonito, la bocca spalancata.
Dice: “Son cose che capitano, signorina, non sa le segnalazioni di ubriachi che sbagliano porta e combinano un casotto. È un quartiere pieno di fuori sede, e alla vostra età si beve senza ritegno”.
Ascolti mentre spiegano la parte burocratica del tuo – come chiamarlo? – quasi tentato stupro. Chiedono se vuoi denunciare, anche se poi non è che gli possono fare più di tanto; mentre parlano sai che stanno per andarsene, e allora dovrai tornare in casa, su quel letto, dove sarai sola. Quando ti accompagnano di sopra, e il tarchiato spiega come fossi una bambina che la chiave è meglio girarla due volte, non riesci a fermare i tremori.
Il basso dice: “Eh, si è presa freddo ad aspettare di sotto, mi spiace”.

Bevi due caffè, insonne, a un orario decente bussi all’amministratore.
Il suo ufficio è costellato di piante di plastica, che non hai mai capito a cosa servano, e alle pareti, come lauree, stanno incorniciati gli articoli che elogiano la riqualificazione della palazzina, un tempo brulicante di spacciatori e prostitute.
Ti fa accomodare, si accorge del tuo pallore. Insiste perché tu beva dell’acqua. I primi venti secondi del tuo racconto li passa a strabuzzare gli occhi, dietro le lenti da medico. Poi con la sua voce meridionale, monotona e decisa, inizia a interromperti, sia per rincuorare, sia per garantire che nel condominio episodi del genere non erano mai accaduti, da quando lui ha dato una bella ripulita. Anzi, precisa, chiamerà il ragazzo, che lavora per un ente pubblico, e gli farà una bella strigliata; le regole nemmeno devono esistere per casi del genere. Anzi, la farà anche alla fidanzata, perché il contratto è a nome di entrambi e quindi lei deve prendersi le proprie responsabilità – e devono scusarsi con te, non si scappa, ci sono gli estremi per rescindere il contratto, clausola 8, articolo 2, comma effe.
Si ripromette, se serve, di far aggiungere un chiavistello alla porta, per star sicuri che tu possa dormire tranquilla. Poi ti farà sapere, dopo aver chiamato in caserma, il numero della pratica, casomai cambiassi idea sul discorso denuncia.
Ringrazi, vi stringete la mano. Mentre gira la maniglia, sorridente, chiedi come mai non t’aveva detto del problema alla porta, che la chiave andava girata.
La mano scatta, la porta si richiude. Con la sua voce, ora frettolosa, ma sempre decisa, ti fa presente che quanto dici è impossibile, è una raccomandazione basilare (ba-si-la-re) per ogni nuovo inquilino, lui ha proprio un decalogo che sciorina come un notaio.
“Magari quel giorno sarai stata distratta, son cose che capitano, no?”
Scuoti la testa, dici che sicuro sarà andata così; vuoi solo uscire, guadagnare spazio e far smettere i tremiti.
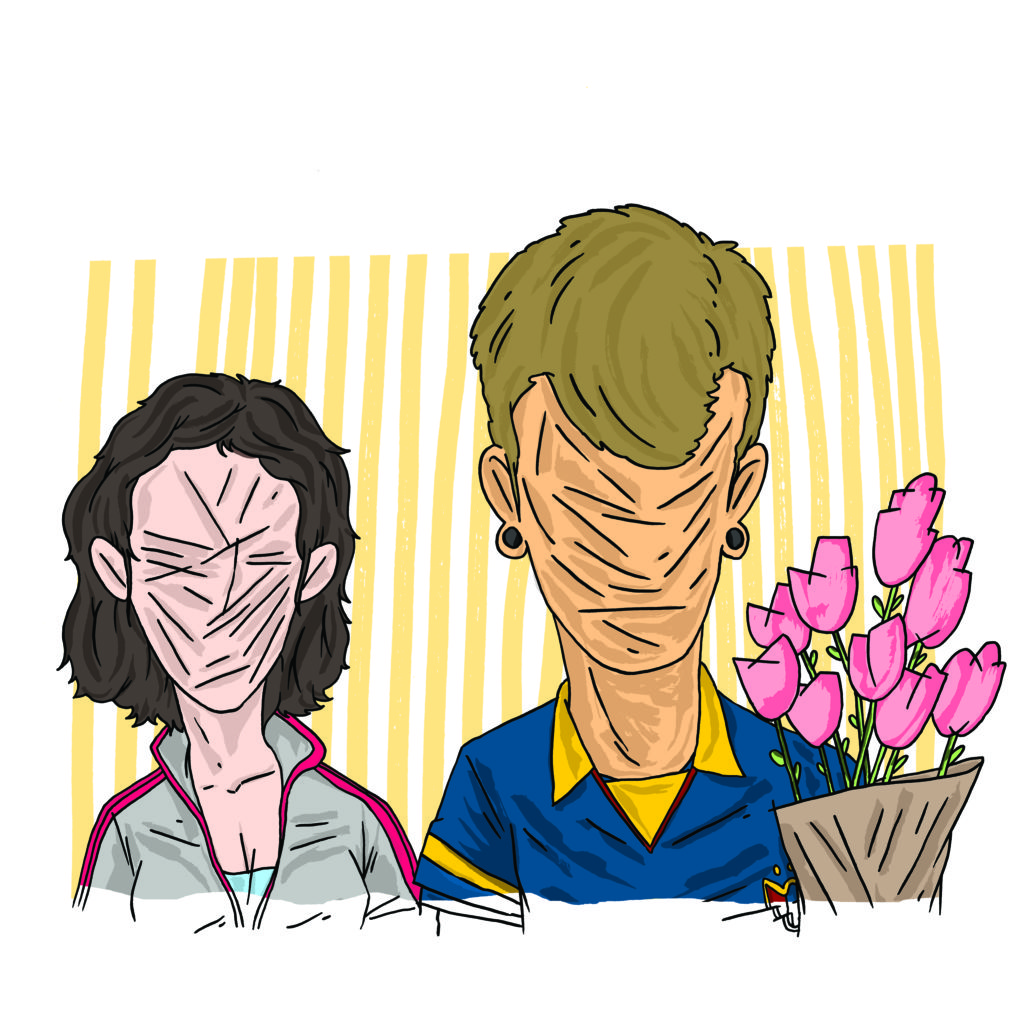
Il trillo ti forza le palpebre. Sei crollata a un certo punto della mattinata, e adesso ti trascini allo spioncino della porta. Forse è pomeriggio, di sicuro non è ora di attaccare, altrimenti avresti chissà quante notifiche. Ancora intontita, sbatti contro lo spigolo del tavolo. Bestemmi.
Dal tondo di vetro lo riconosci. Ha un mazzo di rose bianche in mano. Con lui c’è una ragazza; bionda, una tuta che sa di fine settimana casalingo, la smorfia di tensione sui denti, che uncinano il labbro superiore. Ha una busta di cartone colorato che penzola lungo il fianco.
Il cuore batte come se volesse uscire, aprire la porta e andare oltre quei due.
Lei dice: “Ciao, siamo quelli del piano di sotto, volevamo scusarci”.
Come apri lei si lancia in lacrime ad abbracciarti, il petto che ti si fa umido; il quasi stupratore, intanto, sguscia verso l’interno a capo chino. Si ferma accanto alla ragazza, vi abbraccia entrambe piangendo pure lui. L’alito non puzza più di vodka, ma di tartaro.
“Scusami – dice lui – sono mortificato”.
“Scusaci – fa lei – non abbiamo parole per quello che è successo”.
Scoppi a piangere anche tu, buttando un occhio all’uscio spalancato – hai visto mai che qualcuno passi e veda tre frignoni e una casa in disordine. Ma è il contatto fisico a far montare il disagio, così scansi i loro corpi chiedendo se vogliono qualcosa. Un caffè, dei biscotti.
Lei dice: “No, ci mancherebbe, davvero, non ti disturbare”.
Poi ti dice i nomi di entrambi, vi stringete la mano e dici il tuo, perché si usa così. Restate in piedi, la porta ancora aperta. Nessuno sa bene cosa dire, gli sguardi volteggiano tra il pavimento e rossori di guance; un piede sfrega l’altro e le dita si contraggono.
Lei tira un orecchio a lui, come la padrona che sgrida il cucciolo.
Dice: “Se questo scemo lo faceva a me, sicuro si beccava un calcio nelle palle! Capito? Devi farti rispettare da questi trogloditi”.
Lui offre i fiori, che non sai dove mettere. Lei tira fuori dalla busta color cioccolata fondente un profumo e una bottiglia di whisky, di quello buono e costoso. Appoggia tutto sul tavolo; il tuo tavolo. Gli occhi ti schizzano come palline da flipper: guardi lei, lui, la bottiglia di whisky, ancora lui e infine di nuovo lei.
Brusca afferri i regali, dici alla ragazza: “Riprendeteli pure, non c’è bisogno”.
Lei fa per dire qualcosa, tu insisti: “Vi siete scusati, prendete i regali e andatevene”.
Allora lui si avvicina, spazientito dice: “Guarda che siamo dispiaciuti, eh, non è che siamo qua perché ce l’ha detto l’amministratore, e…”
Quando picchi sul lavandino con la bottiglia, spaccandola, e l’odore pungente invade il piccolo spazio, la coppia arresta parole, sorrisi e imbarazzo, proprio mentre urli loro quello che prima era stato un invito. Chiudi la porta alle loro spalle, ti lasci cadere a terra.
Senti lei stizzita: “Ma tu proprio nell’appartamento di ‘sta cessa isterica dovevi collassare?”
Testo Matteo Pascoletti
Illustrazioni Brochendors Brothers
One thought to “Le cose che capitano”