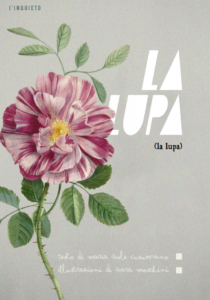
Neri viveva nella morte e invidiava gli animali che la morte non sapevano cosa fosse.
Poche cose lo rassicuravano dal pensiero incessante della fine: le sue montagne; la pacatezza di Ettore; gli occhi di Mina.
Neri di mestiere faceva il beccamorto – o tabutaro, come dicevano in paese – nella ditta che prima era stata di suo padre e prima ancora di suo nonno. S’era abituato presto alle salme, all’odore di alcol e stantio, perché aiutava già da bambino e gli era parso naturale continuare quand’erano rimasti soli, lui e Ettore. Ma forse quel destino ce l’aveva scritto nel sangue dal momento che era nato e, nascendo, aveva ammazzato sua madre. Sul pavimento era schizzato il sangue e Neri stringeva, nella mano da neonato, un pezzo di cordone, come gliel’avesse strappato lui.
Diceva Ettore che le somigliava, nel colore della pelle e dei capelli, nella faccia un po’ mesta e malaticcia, diceva queste cose per consolarlo, ma di quella assurda somiglianza Neri si faceva una colpa.
Aveva iniziato a trarre sollievo dagli altri morti, quelli che doveva conzare per il funerale: uomini e donne masticati e sputati che continuavano a guardarlo da sotto le palpebre bianche, quasi trasparenti. Quella dell’eterno riposo era una bugia, i morti stavano solo immobili e in questo erano simili alle montagne.
Avrebbe voluto fare come Ettore: per lui il lavoro era lavoro, così come il giorno era giorno e la notte era notte. Risaliva al primo piano, si lavava le mani e la faccia, accendeva la radio e cucinava. Non aveva disgusto della carne, che tagliava, affettava, smembrava e poi mangiava. Non lasciava che la sua vita si decomponesse.
Ettore era più grande, più calmo e più buono. Era anche poco socievole, ma per via di una timidezza congenita, e non perché schivo o sospettoso. Si prendeva cura delle salme come fossero tutte di sua madre e suo padre, le guardava con la dolcezza dei suoi occhi marroni. A volte si confidava con loro, a voce bassa, quasi temesse di svegliarle.
Il suo unico difetto era la presunzione che quella mitezza fosse garanzia di una buona condotta. Era impossibile convincerlo d’aver torto se le sue azioni erano mosse da ragionamenti corretti. Loro due avevano discusso più volte per questo motivo, ma mai come quando era arrivata Mina.
Se l’era dato lei quel nome, certe persone portano negli occhi il nome e altre cose. Mina si portava dietro anche la storia di sua madre: bellissima donna che correva nei boschi e stava fuori tutta la notte, si lasciava stringere e baciare dagli uomini, le piacevano alti e forti, con le braccia pelose e il petto pieno. Neri a volte l’aveva sentita ridere mentre faceva l’amore e s’era scoperto geloso di qualcosa che non aveva.
In paese mogli e fidanzate l’accusavano di rubare i compagni e i mariti, allora lei rideva allo stesso modo di quando li prendeva dentro di sé. La chiamavano buttana, lanciavano sassi contro la sua finestra, ma la sera le corse nei boschi si ripetevano.
Mina doveva essere venuta fuori così, figlia di una madre selvatica e di un uomo alto, forte, con le braccia pelose e il petto pieno. S’era presentata alla loro porta con un paio di pinocchietti verdi sporchi di fango, mano nella mano con una vecchia che aveva detto: “Non vi potevo chiamare. Me la dovete sistemare, sennò non me la fanno seppellire”.
Parlava della donna dei boschi. Le si era squarciato il ventre in una delle sue avventure notturne, aveva sul petto segni di morsi che quasi le avevano strappato le areole. Era brutta a vedersi così, e Neri si dispiacque che dopo tanto fantasticare sul suo corpo dovesse toccare a lui prepararla.
“E la bambina?”, aveva chiesto Ettore.
“Tenetemela mezza giornata, il tempo del funerale, ché è piccola e non voglio senta certe porcherie.”
Non era mai venuta a riprendersela, aveva sepolto la figlia e la nipote insieme.
Ettore non voleva averci niente a che fare, anzi voleva andare in paese a cercare la vecchia e dirle che loro non erano delle bambinaie. Neri invece aveva detto che no, non c’era da discutere, Mina, la bambina, restava.
Ne discussero per giorni, senza che l’uno o l’altro cedesse, e alla fine, quasi per inerzia, Ettore si arrese.
“Perché a noi?”, aveva chiesto.
“E perché non a noi, invece.”
Neri aveva guardato il paese, i suoi tetti bassi che con l’inverno si spennellavano di neve, e pareva quasi bello. Aveva chiuso gli occhi, non sentiva niente: le montagne assorbivano tutti i rumori dei paesani, della vita.
Mina da loro imparò a parlare, poco, e a capire, tutto. Solo non voleva lavarsi. Non si lasciava avvicinare, il getto della doccia la spaventava e i suoi capelli s’erano annodati, era impossibile passarci una mano, una spazzola o uno spillo. Costruiva abitudini senza sapere cosa fossero: mangiare alle dodici e mezzo; aspettare che Ettore tornasse dal paese alle sette e le portasse una pasta di mandorle; leggere a voce alta certi libri per bambini a Neri mentre lui conzava il morto di turno; dormire alle dieci, o quantomeno provarci. La maggior parte del tempo la passava con il naso contro il vetro della finestra che dava sul bosco, il suo respiro si condensava e lei ci passava il gomito per tornare a guardare.
“Che guardi?”, le chiedeva Neri, ma a quella domanda non rispondeva mai.
I due fratelli seppellivano i morti e Mina scalava anni di vita: cresceva più veloce degli altri bambini, di quelli che Neri ed Ettore avevano incontrato, quasi degli inciampi fra un funerale e un altro. Catturava lucertole, ci giocava, poi le ammazzava. Sembrava un gatto, ma aveva dei denti bianchi che erano più simili a quelli dei cani.
Ettore e Neri non riuscivano a contenerla, in fondo non volevano. Mina era la radice più resistente del bosco, avrebbe potuto far saltare in aria le assi di casa loro. Per questo poteva stare solo lì, e se fosse scesa in paese avrebbe attirato le maledizioni che per anni s’era presa la madre. Questa consapevolezza fece passare a Ettore ogni residuo di risentimento verso la vecchia e diede a Neri la conferma che un destino di solitudine non si sceglie, semmai si accetta.
Mina, fra tutte le cose, non capiva la morte, che pure aveva sotto i piedi, addosso ai vestiti di Ettore e Neri, nei loro capelli scuri. Non la capiva perché quando uccideva una lucertola non si chiedeva se fosse giusto o sbagliato, lo faceva e basta, perché qualcosa in fondo al suo stomaco la spingeva a farlo. Poi vedeva gente piangere alla loro porta, strillare e strapparsi i capelli, chiedere perché.
Mina una volta lo aveva chiesto anche a Ettore, che aveva mani grandi e un sorriso buono che non mostrava mai i denti, perché la gente moriva e altra gente piangeva.
“Non è che – aveva detto poi – anche le lucertole piangono?”
“Forse lo sanno che è morta una di loro, ma poi se ne dimenticano subito. Le persone invece no.”
Mina l’aveva fissato bene negli occhi e aveva detto: “Io mi dimenticherò di te e tu di me?”.
“Io di te mai, tu di me chissà, vedremo col tempo.”
Tempo era la seconda cosa che Mina capiva poco. Sapeva leggere l’orologio ma non vedeva o non comprendeva gli effetti che il tempo aveva su di lei: la stava trasformando, le aveva gonfiato il seno, ammorbidito i fianchi, ingrossato il naso e affilato le guance.
A sedici anni Mina era un’altra, ma continuava a saltare, inseguire le lucertole, scappare dal getto della doccia, anche se Neri ed Ettore non insistevano più per lavarla.
“Devi tenerti questo addosso”, le aveva spiegato Neri una mattina, quando stava per uscire in mutande, e le aveva dato un vestito.
“Perché?”
“Perché, Mina, perché, sempre con queste domande. Certe cose si fanno e basta.”
“Perché?”
“Mettiti il vestito, va così.”
Mina l’aveva fatto, anche se le dava fastidio perché la stoffa le faceva prurito alle gambe, soprattutto ora che si stavano ricoprendo di peli, folti e nerissimi.
Quello era stato il primo modo in cui il tempo l’aveva ingannata, facendola diventare un’altra senza avvisare.
Il secondo, era stato quando Ettore non era tornato dal paese alle sette.
Cancro, aveva detto Neri. Malattia.
Non aveva detto morte, ma forse la malattia era un’altra parola misteriosa come tempo, che si tirava via le persone e cambiava le cose all’improvviso.
Un giorno Ettore si lamentava con Mina perché aveva strappato di nuovo il vestito, quello dopo era a letto, senza forze. L’avevano tenuto in ospedale il tempo necessario per dirgli che non c’era niente da fare, meglio tornasse a casa.
Questa volta era stato Neri a chiedere a Ettore: “Perché a noi?”.
Ed Ettore aveva risposto, con la solita voce buona: “E perché non a noi, invece?”.
Neri a Mina non aveva saputo spiegarlo, non sapeva spiegarlo nemmeno a se stesso. La morte, pensava, è niente rispetto alla malattia.
L’avevano guardato farsi sempre più piccolo nel letto, respirare piano, fino a emettere solo un debole fischio che faceva ridere e piangere insieme Mina.
Lei non s’era turbata finché non aveva smesso di rispondere alle sue domande, e s’era accorta che era come una di quelle lucertole a cui staccava la coda e poi strozzava, stringendo la testa fra le dita artigliate. La inorridì il pensiero che Ettore morisse allo stesso modo delle lucertole, che anche lui ch’era più grande, più bello e più saggio potesse ridursi a cosa minima, contorcersi nel dolore, digrignare i denti e sudare, supplicare per un po’ d’aria o per la fine.
In tre settimane se n’era andato, in dieci anni sarebbe rimasta di lui solo la polvere, poi nemmeno quella. Neri si era occupato del suo corpo, gli disse tutte le cose che non si erano mai detti in quarant’anni di vita.
Il giorno del funerale c’erano solo loro tre, com’era sempre stato, e un prete imbronciato che ricordava perfettamente la lunga tradizione di famiglia fatta di bestemmie e morti.
Neri aveva riflettuto a lungo se fosse o meno il caso di far venire Mina, poi l’aveva vista in piedi sulla porta con la mano sinistra, che di solito porgeva a Ettore, abbandonata lungo il fianco. Le era parsa sola, orfana per la prima volta. Aveva buttato un sospirone e, dopo aver preso il cappotto, le aveva dato la mano, la sinistra.
La presenza di Mina aveva attirato i paesani, quei pochi che si erano avvicinati passeggiando in mezzo alle lapidi, con i fiori per i loro cari e i lumini con le stampe di Padre Pio.
Lei era stata brava, in silenzio tutto il tempo a succhiarsi il labbro; poi, quando era venuto il momento di seppellire la bara, aveva fatto la matta, s’era messa a mordere e graffiare. Se Neri non l’avesse trattenuta avrebbe colpito il prete e il gruppo di curiosi che, per farsi il segno della croce, avevano fatto cadere fiori e lumini. Era venuta fuori sua madre, la ragazza era scomparsa ed era emersa la lupa, quella che guardava il bosco dalla finestra e pareva dimenticarsi cos’erano le parole.
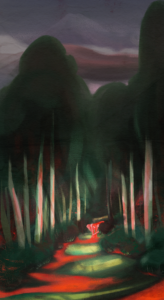
Ora in paese dicevano che era la figlia di Ilde, la ragazza che faceva l’amore nei boschi e che s’era fatta ammazzare dai lupi, o dagli uomini, e le scritte che prima stavano sulla casa della vecchia erano comparse su quella di Neri. Erano scritte cattive e non avevano niente a che fare con Mina, raccontavano una storia mai accaduta. Lei le ignorava, Dio solo sa come ci riusciva, non le leggeva, sceglieva di non leggerle. Ringhiava, denti all’infuori, quando vedeva Neri raschiare via il colore, strofinare forte con una pezzuola imbevuta di candeggina, e sulla fronte gli colava il sudore.
Neri s’era fatto ancora più schivo, se possibile: aveva smesso di lavorare, in tutti i paesani vedeva le macchie di colore, sentiva l’odore di vernice fresca sulle loro facce, li odiava. Odiava anche Mina e la sua indifferenza verso gli uomini che s’abbatteva anche su di lui.
La guardava entrare e uscire dalla porta, grattarsi forte dietro le orecchie, in quella foresta di capelli crespi e annodati, e gli sembrava che neppure si accorgesse che era lì, sulla vecchia poltrona dove sedeva Ettore. A volte aveva l’impressione d’essere morto. E quando non riusciva a dormire e camminava per casa, stropicciandosi gli occhi e pregando per un po’ di sonno, se la ritrovava fra i piedi, accovacciata per terra come un gatto randagio.
Al mattino sperava di vederla seduta al tavolo, magari assonnata, con una tazza di latte in cui affondare il suo bel viso, uguale a quello di Ilde.
Desiderava abbracciarla, carezzarla, tenerla stretta, magari sulle ginocchia, e voleva che Mina facesse lo stesso, che in qualche modo lo amasse, che gli restituisse, insomma, quel che lui aveva fatto per lei in tutti quegli anni.
Una notte pensò d’avere la febbre. Vedeva il soffitto vorticare e accartocciarsi sul materasso striminzito che faceva rumore a ogni suo minimo movimento. Sudava, e dietro la nuca gli pareva d’avere un buco largo quanto una moneta da dove si sprigionava il dolore.
Mina non era tornata. Quando era uscita non aveva detto niente, se n’era accorto solo perché aveva sentito sbattere la porta. Il suo passo era molto più leggero fuori, in mezzo all’erba e alla terra della montagna, che fra le cose che avevano fatto la sua quotidianità.
Stava così male che credette di morire e gli venne da piangere al pensiero che Mina forse non l’avrebbe mai saputo, perché forse non sarebbe tornata.
Al mattino sentì grattare alla porta. Immaginò qualche animale selvatico, una volpe magari, da quando il flusso di clienti si era interrotto erano tornate le bestie: i falchi disegnavano cerchi intorno al comignolo; le lepri saltavano fuori dai cespugli, a volte restavano a fissare Neri attraverso le tendine fiorate del soggiorno; nel buio ululavano i lupi.
Si mise giusto gli occhiali e a piedi nudi, con la testa che scoppiava e quel buco di dolore dietro la nuca, andò a vedere. Era Mina, graffiava perché si era dimenticata come si bussava.
Era nuda e questo fece infuriare Neri: “Dov’è il tuo vestito?”.
Mina indietreggiò, mostrò un poco i denti, il pelo che aveva sulle guance e intorno agli occhi fu come attraversato da un brivido.
“L’hai stracciato? Te l’hanno tolto?”
Lei taceva, s’era dimenticata anche le parole.
“Mi rispondi? Ti ho insegnato a parlare! Io e Ettore ti abbiamo insegnato, non te lo ricordi più? Ti sei dimenticata anche di Ettore?”
Più alzava la voce più Mina scopriva i denti, e il pelo si alzava, i suoi occhi neri si allargavano come il buco di dolore che Neri sentiva dietro la nuca.
D’istinto si portò una mano lì e quasi rimase deluso nel vedere che era tutto normale, c’era la sua pelle, l’attaccatura dei capelli, il colletto del pigiama. Quella stessa mano poi la allungò verso Mina e lei, con uno scatto, gli morse il braccio.
Neri urlò e, come una molla, la mandibola della lupa si riaprì. Ora si leccava il sangue dai denti e dalle labbra, le labbra che erano sempre le stesse e sembrava assurdo che, pur così belle, custodissero quei brutti denti da cane.
Il braccio sgocciolava per terra e sui piedi nudi di Neri, mentre il dolore dietro la nuca si affievoliva. Gli venne da ridere: ecco cos’era, la paura della preda.
“Vieni – disse ricadendo sulla poltrona, la poltrona di Ettore – davvero non ti ricordi?”.
Mina restava immobile sulla porta, nuda e all’improvviso piccina, com’era una volta.
Neri appoggiò il braccio in grembo, in fondo il sangue non era poi tanto, l’avrebbe fasciato dopo. Si tolse gli occhiali, come faceva quando doveva dire qualcosa di importante e voleva che le cose si sgranassero, gli apparissero più distanti.
“Te ne devi andare.”
Mina inspirò, le si allargarono le narici e il nero degli occhi si annacquò. Non era vero che non capiva, Neri glielo lesse in quell’acquerello che aveva fra le palpebre, e dovette impegnarsi per non tornare da lei, farsi mordere ancora nel tentativo di darle una carezza.
Quel buco che sentiva dietro la nuca, già la notte che gli era venuto il febbrone, era Mina che gliel’aveva procurato. Aveva graffiato, aveva morso, aveva scavato fino a sfiorargli la colonna vertebrale. E per colpa sua ora tornava a dolergli quel punto lì, il vuoto che aveva lasciato.
Appena se ne fu andata il foro, ch’era sempre stato una moneta, s’allargò tanto da inghiottire il resto e lui, guardandosi intorno, vide che non era rimasto niente. In fondo, aveva mai avuto davvero qualcosa? Credeva d’avere Mina, che fosse diventata sua perché se l’era cresciuta, l’aveva educata, e questo bastava, s’era cullato in quell’illusione. Ora l’avrebbe richiamata indietro, avrebbe gridato il suo nome mille volte e mille altre ancora, i cani tornano sempre al proprio padrone. Ma lui non cercava una docile cagna da carezzare che l’accompagnasse fino alla morte, no, lui cercava una lupa che masticasse quella carne sola e abbandonata, così sarebbe divenuto parte di Mina e allora sì che la sua misera esistenza avrebbe contato qualcosa.
Testo Maria Sole Cusumano
Illustrazione Sara Moschini