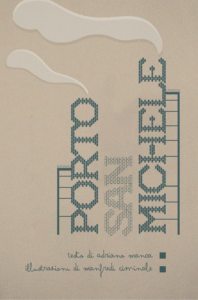
Sparai un rutto di quelli clamorosi. Ludovica mi guardò disgustata, divertito soffiai verso di lei, in caso non avesse potuto comprendere appieno la portata del rutto.
“Sei un coglione.”
Si alzò e se ne andò, seguita da quello zerbino di Gianluca. Che dire, doveva esserci una sorta di guinzaglio con cui lo trascinava, impercettibile per noi comuni mortali.
Lo dico da amico sia chiaro. Gianluca era un miracolo della genetica. Il padre era una delle persone più rozze e stupide che avessi mai conosciuto, la madre, beh, qualora capitaste da queste parti, provate a chiedere di Milena Vannucchi, poi ne riparliamo.
Fatto sta che da questi due nacque Gianluca, che già a otto anni mi rompeva i coglioni con cose di cui onestamente a me non fregava niente: codice genetico, biologia, chimica, boh, cose così. E non lo dico solo io, che era bravo, l’anno scorso ha vinto una borsa di dottorato negli Stati Uniti, in un laboratorio di un’università di queste famose, quelle che si vedono nei film, tipo Harvard, no, non era Harvard, è per darvi l’idea. Ovviamente ha rifiutato, per stare con Ludovica.
Ludovica è un pozzo, lo è sempre stato, fin da ragazzini, quando giocavamo a nascondino attorno alla chiesa del patrono. Spariva per ore e dovevamo cercarla per tutto il paese, ricompariva come niente fosse, con quel suo sorriso di una bellezza sadica, consapevole di essere inarrivabile.
Un pozzo senza fondo, Ludovica, al massimo uno può provare un po’ a scendere in caduta libera, finché a un certo punto non realizza che la discesa non finirà mai, perché ti guarda dai lati, dalle pareti del pozzo, ma al fondo, alla sua vera natura, non ci arrivi.
Ovviamente sono innamorato di Ludovica, o forse no, non lo so, la amo come una zanzara può amare quella gabbietta con la luce colorata che la attira e poi la frigge, ecco, questo è il modo migliore per spiegare come funziona tra me e lei.
Non che sia una cosa brutta, non sempre, a volte è bello lasciarsi andare giù per il pozzo. Almeno io ne esco, Gianluca sono dieci anni che ci cade e lo continuerà a fare. Credo che a un certo punto si renderà conto di quello a cui ha rinunciato per lei e si ammazzerà, o forse no, forse esplorare Ludovica è un’impresa degna di un Nobel per la fisica, come esplorare un buco nero, o una porzione di universo ritenuta irraggiungibile, Gianluca sta dedicando la sua intera esistenza a questa impresa disperata. Mette insieme ipotesi, scoperte, pensa di poterla definire, poi lei si spara una striscia di cocaina e si tuffa da venti metri dal ponte degli Austriaci. E magari non aveva mai tirato cocaina prima di quel momento, per capirci.
Salutai quel branco di coglioni che chiamo amici, e quando li chiamo coglioni non lo dico per disprezzo, io sono il peggior coglione di Porto San Michele, ma questa è un’altra storia. Presi il motorino e ci montai sopra, poi un ripensamento. Chiamai Livia, le feci un sorrisone idiota, di quelli che inteneriscono tipe come lei, crocerossina nata ben disposta a regalarti una scopata per un sorriso ben fatto. Fece finta di niente, quella sera ne voleva da Lupin, all’anagrafe Michele Gigliotti, grande professionista. D’inverno viveva di rendita con i proventi dell’attività estiva, che come avrete intuito consisteva nel rubare, nello specifico nel rubare dentro le case dei turisti. Non solo qui a Porto, ma in tutto il litorale, ogni tanto si faceva anche delle trasferte con amici suoi, andavano su al Nord.
Accettai l’idea di non scopare per quella sera, non la presi benissimo. Era un mesetto che non vedevo figa e la cosa iniziava a pesarmi, più che altro iniziavo a sembrare uno di quei viscidi che manca poco gli parte la salivazione tipo cani di Pavlov appena vedono un essere di sesso femminile.
Per tornare a casa feci la litoranea. In lontananza le luci rosse delle ciminiere della raffineria sembravano gli occhi intermittenti di una bestia notturna. Quando il vento tirava verso il paese, la gente se ne stava in casa, tutti sapevano che dentro quell’aria c’era la merda, nessuno diceva granché, ogni tanto arrivava qualche inviato televisivo, se ne parlava per qualche giorno, finiva lì. Senza la raffineria il paese sarebbe morto, eravamo un bel pacchetto di anime perse, quand’ero piccolo facevo spesso questo sogno in cui tutto appariva normalissimo, i miei, gli amici, tutto, poi, a un certo punto, non mi ricordo più tanto bene, un cane mordeva la mano di un ragazzino e non usciva sangue, ma fumo, grigio e denso. Il bambino, sconvolto, iniziava a scorticarsi la mano già lacerata, si strappava via tutta la pelle, finché non iniziava a urlare, perché scopriva di non essere fatto di carne ma di fumo denso che si attorcigliava in vortici vivi e sibilanti.

Dopo cena, andai con Marcellino e Spranga al bar del padre di Ludovica, dove almeno avrei visto la madre. Non era più un granché, ma in passato aveva colonizzato le menti di quasi tutti gli adolescenti arrapati di Porto San Michele, peggio di un virus, peggio di una droga.
Non volevo fare tardi, il giorno dopo avevo un servizio di catering. Una cena dai Sonetti, quelli dei surgelati. Avevano una villa poco fuori città, una roba incredibile, dire pacchiana sarebbe un eufemismo.
Iniziai a bere, cocktail del cazzo fatti con la sottomarca della sottomarca, ma costavano poco e ti spaccavano la testa che neanche una martellata. Spranga, come suo solito, si attaccò alle slot machine, il posacenere a portata di mano. Mi sorrise coi suoi denti incrostati di nicotina, perfino i capelli ricordavano il colore del tabacco.
Marcellino intanto si era messo a giocare a carte con quelli dell’officina, urlavano come dei matti a ogni presa. Giocavano con il mazzo della Real San Michele, Marcellino ne andava fierissimo, un ricordo di quando era considerato da tutti, perlomeno in paese, come la più grande promessa calcistica dell’intera regione, o della nazione, secondo alcuni. Ma era solo grosso e furbo, non appena passò alla Fiorentina i suoi limiti vennero a galla. Durò sei mesi, poi tornò al paese. Ora gioca in Eccellenza, ha due figlie e si è sposato con la tabaccaia di via Grassi, quella da cui si era fatto fare un pompino per pietà durante la gita a Stoccarda.
La musica era altissima, un pezzo commerciale, di quelli che ti ascolti d’estate in discoteca, spaccato di brutto, tutto bassi e poco altro, con qualche vocina sopra, meglio se femminile e un po’ troia.
Mi veniva da vomitare, corsi verso il bagno e mi svuotai lo stomaco dello schifo che avevo dentro. Non c’era mai la carta igienica. Mi asciugai con il polsino della camicia, tanto l’avrei messa a lavare.
Chiesi a Vito perché non ci fosse carta igienica, mi guardò divertito.
“Ce la fregano sempre cazzo, non c’è verso, non dura un minuto.”
Sorrisi e mi avviai verso l’uscita per tornarmene a casa, la mattina dopo mi sarei dovuto svegliare alle otto, dovevo aiutare per l’allestimento alla villa dei Sonetti.
Ero a piedi, dato che mi ero fatto accompagnare da Spranga in macchina e al momento il soggetto in questione pareva incapace di intendere e di volere. Lo guardai, mi sorrise di nuovo coi suoi occhi vuoti. Spranga era il bambino del mio sogno. Lo invidiavo, avrei voluto essere fatto di quel fumo anch’io, il cervello come un ammasso di nuvole, smosse solo dalle correnti atmosferiche della sua testa, altrimenti vuota.
Mi incamminai verso casa, da sotto il tornante si vedevano le luci del paese, sul lungomare c’erano un po’ di liceali a fumare.
Oltre il paese, verso punta dei Corsari, si scorgeva una delle torri. Un parallelepipedo arrugginito, che di notte emetteva bagliori a intervalli irregolari. Ce n’erano quattordici, ero entrato in tutte quante, certo, dopo che le recinzioni, i sorveglianti e le telecamere se ne erano andati.
Non frega più un cazzo a nessuno delle torri ora. Se proprio volete saperlo, neanche a me frega un cazzo.
La mattina dopo, alle otto e quarantacinque, ero di fronte a Villa Sonetti. Marco, il capo servizio, mi fece un cazziatone assurdo, niente di nuovo. In fondo era un buon cristiano, bravissima persona, ogni tanto andavamo insieme a pescare. Avevano già scaricato il furgone, quindi la parte più faticosa me l’ero scampata, ottimo. Mi dissero di lucidare i candelabri, la faccenda più odiosa che potessero accollarmi. Mi misi a sedere, Carola mi lanciò un’occhiataccia.
Lei non si sedeva mai, non beveva, amava fare la cameriera, interagire con le persone. Si sentiva soddisfatta quando nel ristorante in cui lavorava durante la settimana un cliente prendeva un piatto che lei gli aveva consigliato, cazzo, neanche lo avesse preparato lei con quelle sue manine delicate, da pianista mancata. E non la pagavano mica bene, gli davano una miseria, ma lei era contenta così. Mi piaceva scopare con Carola, avevo l’impressione di contaminarla, o forse no, la verità è che mi piaceva toccare qualcosa di così puro, di così bianco, con le mie mani lerce. Al tempo stesso mi faceva sentire una merda, al suo cospetto mi sentivo ancora più sporco, lurido, ancora più insignificante.
Carola era una finta scema, ogni tanto ci avevo parlato un po’ più a lungo, era una persona poetica, anche se non so bene come definire un individuo del genere, però lo era, faceva lunghe passeggiate, la notte, da sola. Il marito non tollerava questa sua stranezza, pensava avesse un amante o cose così. Di amanti, a dire il vero, ne aveva diversi, ma il più delle volte, quando di notte non stava a casa, era perché se ne andava in giro per spiagge, boschi o che so io. Leggeva solo poesie di ‘sto tizio, Pessoa, un portoghese, ah, soffriva d’insonnia, questo spiega le camminate notturne. Aveva un bel sorriso, pieno, non falso o ebete, ma il più delle volte la odiavo, mi faceva schifo la sua felicità, non ne capivo la fonte. Vale anche per gli altri, io davvero non capisco che cazzo ci sia da sorridere in questo formicaio a cielo aperto.
Verso le sette, quando il sole stava iniziando lento a tramontare, avevamo finito tutto, gli ospiti sarebbero arrivati in mezz’ora. Entrai dentro casa, i figli dei Sonetti, avranno avuto cinque anni lui e sei lei, stavano facendo lezione di recitazione, la loro insegnante gli stava spiegando come usare la voce senza sforzare troppo le corde vocali, usando il diaframma.
Il bambino guardava con insistenza in direzione della Playstation che stava sotto la televisione.
Facemmo il briefing, ovvero la riunione per assegnare i ruoli a ognuno. Marco ci chiamò a raccolta ai piedi della cascata artificiale. Era il vanto di casa Sonetti, insieme al campo da calcio, da tennis e alla piscina con mosaico finto-romano.
Era una cascata che scorreva lungo una parete rocciosa, sarà stata alta dieci metri, o forse quindici. Ci si arrivava attraverso una lunga scala, all’inizio della quale c’erano due enormi teste di Buddha.
Mi assegnarono il tavolo dei bambini, almeno non avrei potuto fare danni . Feci persino amicizia con l’animatrice, due tette incredibili.

Il giorno dopo incontrai Ludovica al bar di Gino, facemmo colazione insieme. Per un attimo sentii la chiamata alle armi riecheggiare dentro di me, sentii l’impulso di lanciarmi un’altra volta dentro al pozzo. Fortunatamente la notte precedente ero riuscito a farmi l’animatrice e quindi ero in grado di mantenere un minimo di contegno e un minimo di capacità intellettuale per non buttarmi nel pozzo-Ludovica. Lei probabilmente aveva odorato qualcosa di quello che mi passava per la testa, perché mi guardava con quel sorriso di merda con cui di solito prende per il culo la gente.
Cazzo se era bella. Dal bar vedevo il mare e sentivo, in modo cristallino, il rumore delle piccole onde che sbattevano calme sul moletto. La guardai e c’era tutto, avrei volentieri posto fine alla mia esistenza in quel momento. Una bella scena, piena, una di quelle che non hanno bisogno di ulteriori postille o parole, o aggiunte qualsiasi.
“Gianluca è fuori, a Firenze, per un colloquio di lavoro, che facciamo pomeriggio?”
“Andiamo a tuffarci da punta dei Corsari, e dopo ci beviamo un po’ di birre e ci mangiamo una pizza.”
“Quanto sei alternativo, come fai ad avere continuamente idee nuove, eh? Hai fatto una scuola speciale?”
La mandai affanculo, ma alla punta ci andammo lo stesso. Feci due o tre tuffi, sono bravo, mi aveva insegnato mio padre prima di andare a Cuba con una, non ricordo il nome. Aveva un ristorante, mio padre. E una Porsche, ogni tanto mi ci portava in giro. Cucinava benissimo.
Il sole era sparito dietro capo San Benedetto. Le cose erano illuminate da un alone violetto e si sentiva l’odore della macchia mediterranea.
“Andiamo alla torre nove?”
“D’accordo.”
“Ti tuffi da lì poi?”
“Non so, sta facendo buio”
“Sai che se insistessi ti butteresti, vero?”
“Non dire stronzate, non sono Gianluca.”
“No, infatti.”
Arrivammo ai piedi del parallelepipedo arrugginito, entrammo. Qualcuno si era fregato il portellone, chissà per farci cosa. Qui rubano tutto, è inspiegabile. Non è una questione di povertà, perché spariscono penne, carta igienica nei bar, tricicli di bambini, perfino alberi da frutta, forse è una forma di resistenza al congelamento, alla cementificazione della vita in questo paese schifoso, non so. O forse anche le cose si rompono i coglioni a stare qui, e spariscono.
Dentro era pieno di bottiglie, siringhe, immondizia varia, le pareti di metallo erano ricoperte di scritte, perlopiù numeri di telefono di persone superdotate, o di fighe affamate, cose così. Qualche scritta politica, contro la chiesa o il sindaco Marini, quello che aveva fatto fallire la Real San Michele.
Entrammo nella sala dei generatori, ogni volta che ne sentivo il ronzio sommesso lo stomaco mi si attorcigliava, come se una mano mi stringesse le budella e me le rigirasse. Tre enormi cubi, ognuno al centro aveva due pulsanti, uno giallo e uno blu, e due lucine accese dello stesso colore sopra ognuno dei pulsanti. Mio nonno mi raccontava che quelle lucine non si erano mai spente, che i generatori erano sempre rimasti attivi.
Sotto i pulsanti, l’intera metà inferiore della facciata frontale del cubo era occupata da un messaggio scritto in quel linguaggio intraducibile. Non lo dico solo io, quando qui c’era l’esercito immagino avranno fatto un sacco di ricerche, ma Gino, giù al bar, dice che sa da fonti certe che sono andati via perché hanno fallito, non sono neanche riusciti ad aprire i cubi, nemmeno una volta. Quand’ero piccolo dalle torri spesso si sentivano esplosioni.
Il ronzio continuava, sereno, come i grilli o le cicale, perfettamente assorbito nel paesaggio circostante. Lo stesso si poteva dire per le torri arrugginite.
Ormai era quasi totalmente buio, si vedevano le luci delle case di campagna. Ludovica mi passò l’asciugamano, ero risalito a memoria, senza vederci un granché. Mi facevano male le braccia perché non le avevo tenute attaccate al corpo al momento dell’impatto con l’acqua, mi ero tuffato di piedi. Non avevo più i coglioni per tuffarmi di testa.
“Ogni tanto penso che vorrei essere una di quelle lumache di mare di cui mi parla Gianluca.”
“Eh?”
“Non mi ricordo il nome, ma appena nate hanno due occhi, o qualcosa di simile a degli occhi, poi si cercano uno scoglio bello comodo dove attaccarsi, la cosa interessante è che dopo essersi attaccate, perdono gli occhi e pure il cervello, in senso letterale. Non ne hanno più bisogno, visto che passeranno la loro intera esistenza su quello scoglio a fare sempre la stessa cosa. Mi sarebbe piaciuto poter fare così.”
“E quando avresti voluto perdere occhi e cervello? Dopo il liceo? A quei tempi un po’ ci si divertiva.”
“No, credo dopo le elementari, o forse prima. Sarebbe stato bello, no?”
“Sì, può darsi.”
Quando tornai a casa, sul tavolo trovai un piatto di pasta al ragù e un biglietto di mia madre. Il giorno dopo avevo un servizio di catering, un matrimonio.
Testo Adriano Manca
Illustrazioni Manfredi Ciminale
One thought to “Porto San Michele”